Il monopolio statale del collocamento e l’avviamento al lavoro su richiesta numerica, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo tramite agenzia, l’inderogabilità del contratto collettivo nazionale da parte di quello aziendale, l’articolo 18 dello Statuto
.
Il mio intervento introduttivo al convegno promosso per la discussione del libro Mezzo secolo di diritto del lavoro da Assindustria a Firenze il 27 marzo 2027, con la partecipazione del suo presidente Maurizio Bigazzi, della professoressa Maria Luisa Vallauri, del Presidente emerito della Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze Vincenzo Nuvoli e dell’avvocato giuslavorista Andrea Del Re – In argomento v. anche le slides utilizzate per la presentazione del libro all’Università degli Studi di Milano il 22 gennaio 2025
.
 Tre anni fa, un gruppo di giovani giuslavoristi mi propose di ripubblicare una selezione di miei scritti pubblicati nell’arco di tutta la mia vita adulta – da uno del 1976 sul fenomeno dell’aumento delle assenze dal lavoro registratosi dopo l’entrata in vigore dell0 Statuto dei lavoratori a uno sul rovesciamento del paradigma del mercato del lavoro pubblicato nel 2020 – accompagnando ciascuno di questi scritti con un’ampia intervista sul contesto in cui esso era nato, il suo retroscena politico-sindacale e accademico, nonché l’attualità perdurante o no della tesi allora sostenuta. Quando accettai quella proposta non avevo chiaro che cosa sarebbe uscito dall’impegnativo lavoro di scavo nella memoria che essa comportava.
Tre anni fa, un gruppo di giovani giuslavoristi mi propose di ripubblicare una selezione di miei scritti pubblicati nell’arco di tutta la mia vita adulta – da uno del 1976 sul fenomeno dell’aumento delle assenze dal lavoro registratosi dopo l’entrata in vigore dell0 Statuto dei lavoratori a uno sul rovesciamento del paradigma del mercato del lavoro pubblicato nel 2020 – accompagnando ciascuno di questi scritti con un’ampia intervista sul contesto in cui esso era nato, il suo retroscena politico-sindacale e accademico, nonché l’attualità perdurante o no della tesi allora sostenuta. Quando accettai quella proposta non avevo chiaro che cosa sarebbe uscito dall’impegnativo lavoro di scavo nella memoria che essa comportava.
Quando ho riletto l’intero volume per la correzione delle bozze, la cosa che mi ha colpito di più è stata la constatazione di quanti tabù del nostro diritto del lavoro sono caduti nell’arco di ques’ultimo mezzo secolo: veri e propri blocchi mentali che hanno paralizzato per decenni il nostro sistema delle relazioni industriali, condannandolo a un ritardo grave rispetto a quelli di quasi tutti gli altri ordinamenti dell’Occidente sviluppato.
 1. Il primo contro il quale mi scontrai, nella seconda metà degli anni ’70, è stato il tabù del monopolio statale dei servizi di collocamento, con il suo corollario costituito dalla regola generale dell’avviamento al lavoro su richiesta numerica secondo una graduatoria essenzialmente fondata sull’anzianità di iscrizione alla lista di disoccupazione. Dei danni prodotti da questo sistema avevo fatto esperienza diretta nel mio lavoro di coordinatore dei servizi legali della Camera del Lavoro di Milano: era frequentissimo ricevere persone – soprattutto giovani – sconcertate e frustrate perché avevano trovato il lavoro ma non potevano farsi assumere in conseguenza di quella regola (salvo pagare la mazzetta al collocatore per ottenere di “scavalcare la graduatoria”). Alla gravissima disfunzione causata da quel regime dedicai il libro Il collocamento impossibile, pubblicato nel 1982.
1. Il primo contro il quale mi scontrai, nella seconda metà degli anni ’70, è stato il tabù del monopolio statale dei servizi di collocamento, con il suo corollario costituito dalla regola generale dell’avviamento al lavoro su richiesta numerica secondo una graduatoria essenzialmente fondata sull’anzianità di iscrizione alla lista di disoccupazione. Dei danni prodotti da questo sistema avevo fatto esperienza diretta nel mio lavoro di coordinatore dei servizi legali della Camera del Lavoro di Milano: era frequentissimo ricevere persone – soprattutto giovani – sconcertate e frustrate perché avevano trovato il lavoro ma non potevano farsi assumere in conseguenza di quella regola (salvo pagare la mazzetta al collocatore per ottenere di “scavalcare la graduatoria”). Alla gravissima disfunzione causata da quel regime dedicai il libro Il collocamento impossibile, pubblicato nel 1982.
La cosa che può apparire incredibile oggi è che quel regime oppressivo era difeso non soltanto dal Partito comunista e dal Partito socialista, ma anche dalla Democrazia cristiana: democristiano era il ministro del Lavoro Amintore Fanfani che ne aveva promosso l’istituzione nel 1949 e prevalentemente democristiani i “collocatori statali”, il cui sindacato autonomo era confluito nella Cisl. Ma ancora più incredibile è che la Corte costituzionale fosse all’epoca tanto profondamente permeata dall’opinione politica dominante, che nella seconda metà degli anni ’80, investita della questione di legittimità e ragionevolezza di quel regime, emise una sentenza (n. 203/1987) che ne sanciva addirittura la necessità e irreversibilità sulla base del principio generale di protezione del lavoro. Solo quattro anni dopo – ministro del Lavoro Gino Giugni – la legge n. 223/1991 avrebbe abrogato la regola dell’avviamento al lavoro su richiesta numerica secondo la graduatoria; dopodiché nessuno si sognò di impugnare quella legge alla luce della sentenza della Consulta, che venne infatti prontamente dimenticata.
Per il superamento del monopolio statale dei servizi di collocamento si dovette invece attendere la sentenza della Corte di Giustizia europea Job Centre II del dicembre 1997, cui fece prontamente seguito un decreto legislativo emanato dal ministro del Lavoro Tiziano Treu. Sarà un caso che a rimuovere questo grande macigno sulla strada della modernizzazione del nostro sistema delle relazioni industriali siano stati due grandi ministri del Lavoro, appartenenti entrambi a Governi di Centro-Sinistra?
 2. Un altro tabù della nostra cultura giuslavoristica negli anni ’70 e primi anni ’80 era il lavoro a tempo parziale: Pci e Cgil si opponevano al riconoscimento di questa forma di determinazione e organizzazione del tempo di lavoro, essenzialmente perché essa comportava uno spazio di autonomia individuale nella negoziazione delle condizioni di lavoro tra l’impresa e la persona che viveva del proprio lavoro (era l’epoca in cui anche in seno all’accademia prevaleva la concezione acontrattualistica del rapporto di lavoro). A sostenere la tesi contraria, e in particolare la necessità del riconoscimento pieno dell’autonomia negoziale individuale in materia di determinazione della collocazione ed estensione temporale della prestazione di lavoro (ovviamente entro il limite massimo stabilito dalla legge) dedicai un progetto di legge nel 1981 e il libro sul Tempo della prestazione di lavoro, pubblicato nel 1984.
2. Un altro tabù della nostra cultura giuslavoristica negli anni ’70 e primi anni ’80 era il lavoro a tempo parziale: Pci e Cgil si opponevano al riconoscimento di questa forma di determinazione e organizzazione del tempo di lavoro, essenzialmente perché essa comportava uno spazio di autonomia individuale nella negoziazione delle condizioni di lavoro tra l’impresa e la persona che viveva del proprio lavoro (era l’epoca in cui anche in seno all’accademia prevaleva la concezione acontrattualistica del rapporto di lavoro). A sostenere la tesi contraria, e in particolare la necessità del riconoscimento pieno dell’autonomia negoziale individuale in materia di determinazione della collocazione ed estensione temporale della prestazione di lavoro (ovviamente entro il limite massimo stabilito dalla legge) dedicai un progetto di legge nel 1981 e il libro sul Tempo della prestazione di lavoro, pubblicato nel 1984.
Quando, in quello stesso anno, il Governo Craxi decise di infrangere questo tabù a costo di uno scontro in Parlamento, il Pci e la Cgil vi si opposero con vigore. A quarant’anni di distanza credo che non ci sia più nessuno, neanche all’estrema sinistra, che si sognerebbe di proporre il ritorno al regime precedente su questa materia.
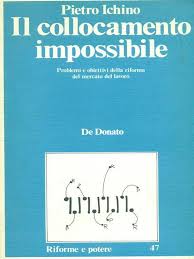 3. Un terzo tabù del nostro diritto del lavoro è stato il lavoro temporaneo tramite agenzia: ancora negli anni ’90 l’Italia era, con la Grecia, l’ultimo Paese dell’Europa occidentale dove questo servizio fosse vietato. Anche per il superamento di questo vero e proprio blocco mentale non fu sufficiente il dibattito interno (cui contribuii con un articolo sulla rivista diretta da Giuseppe Pera del 1992 e altri successivi su riviste diverse): fu necessaria ancora la sentenza Job Centre II della Corte di Giustizia Europea del 1997, che impose all’Italia di rimuovere il divieto e di dettare una disciplina ragionevole di questo servizio, necessario al buon funzionamento del mercato del lavoro.
3. Un terzo tabù del nostro diritto del lavoro è stato il lavoro temporaneo tramite agenzia: ancora negli anni ’90 l’Italia era, con la Grecia, l’ultimo Paese dell’Europa occidentale dove questo servizio fosse vietato. Anche per il superamento di questo vero e proprio blocco mentale non fu sufficiente il dibattito interno (cui contribuii con un articolo sulla rivista diretta da Giuseppe Pera del 1992 e altri successivi su riviste diverse): fu necessaria ancora la sentenza Job Centre II della Corte di Giustizia Europea del 1997, che impose all’Italia di rimuovere il divieto e di dettare una disciplina ragionevole di questo servizio, necessario al buon funzionamento del mercato del lavoro.
Oggi, a venticinque anni di distanza da quella svolta che ci è stata imposta dall’ordinamento europeo, il lavoro temporaneo tramite agenzia è riconosciuto da tutti come un canale assai utile di accesso al tessuto produttivo: accesso in forma temporaneamente precaria, ma pur sempre trasparente e con applicazione di tutti gli standard protettivi, con un alto tasso di transizioni al lavoro ordinario a tempo indeterminato. Tanto che anche su questa materia nessuno, neanche all’estrema sinistra, si sognerebbe di proporre di tornare al regime precedente di drastico divieto di questo servizio al mercato del lavoro.
4. Di un quarto tabù che caratterizzava negativamente il nostro sistema delle relazioni industriali mi resi conto al passaggio del millennio, quando accadde un fatto paradossale. Per curiosa coincidenza nella primavera del 2000, proprio quando la Fiat – cui nel 1986 l’IRI aveva ceduto a poco prezzo l’Alfa Romeo – annunciò la chiusura dello stabilimento di Arese, che dava lavoro a 5.000 lavoratori, la giapponese Nissan lanciava un contest per l’insediamento in area euro di un suo grande stabilimento automobilistico; risposero con la propria candidatura Flins, vicino a Parigi, dove già operava una joint venture Nissan-Renault, Erfurt in Turingia e Sunderland nel nord-Inghilterra, ma nessuno si sognò di candidare Arese. Perché?
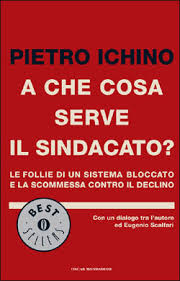 Quando lo chiesi pubblicamente mi si rispose che il sistema di organizzazione del lavoro praticato dalla Nissan era la lean production (che prevedeva il lavoro degli operai in team, con inquadramento di tutti allo stesso livello professionale, con determinazione del 30 per cento della retribuzione sulla base di una performance review periodica): un sistema incompatibile con il contratto collettivo del settore metalmeccanico. Da quell’episodio trassi lo spunto per un libro, A che cosa serve il sindacato, pubblicato nel 2005, dove sostenevo che il mestiere più importante del sindacato, nell’era della globalizzazione, era quello di valutare i nuovi piani industriali e la qualità e capacità degli imprenditori che li proponevano; e, nel caso di valutazione positiva, quello di guidare i lavoratori nella scommessa comune con l’imprenditore sul piano industriale migliore; ma osservavo che questo avrebbe comportato il riconoscimento della derogabilità del contratto collettivo nazionale da parte del contratto aziendale stipulato da una coalizione sindacale maggioritaria.
Quando lo chiesi pubblicamente mi si rispose che il sistema di organizzazione del lavoro praticato dalla Nissan era la lean production (che prevedeva il lavoro degli operai in team, con inquadramento di tutti allo stesso livello professionale, con determinazione del 30 per cento della retribuzione sulla base di una performance review periodica): un sistema incompatibile con il contratto collettivo del settore metalmeccanico. Da quell’episodio trassi lo spunto per un libro, A che cosa serve il sindacato, pubblicato nel 2005, dove sostenevo che il mestiere più importante del sindacato, nell’era della globalizzazione, era quello di valutare i nuovi piani industriali e la qualità e capacità degli imprenditori che li proponevano; e, nel caso di valutazione positiva, quello di guidare i lavoratori nella scommessa comune con l’imprenditore sul piano industriale migliore; ma osservavo che questo avrebbe comportato il riconoscimento della derogabilità del contratto collettivo nazionale da parte del contratto aziendale stipulato da una coalizione sindacale maggioritaria.
Contro quel libro la Cgil cercò di stendere una sorta di “cordone sanitario” e vi fu anche chi dagli uffici di Corso d’Italia 25 lanciò contro di esso una vera e propria fatwa. Sta di fatto, però, che il bubbone era destinato a scoppiare: ciò che avvenne cinque anni dopo, nel 2010, quando in una FIAT tecnicamente in stato fallimentare il nuovo A.D. Sergio Marchionne presentò un piano industriale capace di risollevarla, che però prevedeva tre rilevanti deroghe rispetto al contratto collettivo nazionale del settore. La Cgil lo rifiutò proprio a causa di quelle tre deroghe, mentre Cisl, Uil e Fismic ne diedero una valutazione positiva; e i referendum negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco, Mirafiori e Grugliasco diedero loro ragione. Già un anno dopo, nel giugno 2011, la Confindutria avrebbe sottoscritto con tutte e tre le Confederazioni sindacali maggiori – Cgil compresa – un accordo interconfederale che sanciva la derogabilità del contratto collettivo nazionale da parte del contratto aziendale stipulato da una coalizione sindacale maggioritaria, accordo tuttora in vigore.
5. Il quinto tabù – il più duro a morire – era quello dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970: la regola, cioè, che prevedeva la reintegrazione nel posto di lavoro della persona licenziata in tutti i casi non solo di illiceità del motivo del recesso, ma anche di sua mera irregolarità formale, o di insufficienza del motivo ritenuta dal giudice.
Nel 1996, con il libro Il lavoro e il mercato, avevo sostenuto la necessità del superamento di questa regola, che pretendeva di applicare nel settore privato un regime di sostanziale job property analogo a quello applicabile nel settore dell’impiego pubblico. A questa mia proposta si obiettò che la reintegrazione nel posto di lavoro costituiva – nientemeno – un diritto fondamentale della persona; ma come poteva essere che un diritto fondamenale della persona fosse riconosciuto solo a metà della forza-lavoro italiana in posizione di sostanziale dipendenza (con esclusione di quattro milioni di dipendenti di mini-imprese, due milioni di lavoratori a tempo parziale e due milioni di collaboratori autonomi continuativi)? E come poteva considerarsi “diritto fondamentale della persona” un diritto che non era riconosciuto alla generalità dei lavoratori in nessun altro Paese dell’Occidente sviluppato?
 Anche questo, che Aris Accornero indicò come “l’ultimo tabù”, era comunque destinato a cadere. Il che avvenne quando la Banca Centrale Europea lo indicò all’Italia come condizione perché la BCE stessa potesse farsi carico dell’acquisto massiccio dei titoli del debito italiano nel momento in cui la crisi del debito stesso aveva raggiunto il suo punto più grave (il riferimento è alla famosissima lettera del Governatore uscente Trichet e dell’entrante Draghi al Governo italiano del 5 agosto 2011). Meno di un anno dopo è stata avviata, con la legge Fornero 28 giugno 2012 la riforma della materia che ha posto come regola generale, in tutti i casi in cui il giudice ritenga il motivo del licenziamento insufficiente, l’applicabilità di una sanzione di natura indennitaria; riforma poi rafforzata per tutti i nuovi rapporti di lavoro con il Jobs Act del 2015.
Anche questo, che Aris Accornero indicò come “l’ultimo tabù”, era comunque destinato a cadere. Il che avvenne quando la Banca Centrale Europea lo indicò all’Italia come condizione perché la BCE stessa potesse farsi carico dell’acquisto massiccio dei titoli del debito italiano nel momento in cui la crisi del debito stesso aveva raggiunto il suo punto più grave (il riferimento è alla famosissima lettera del Governatore uscente Trichet e dell’entrante Draghi al Governo italiano del 5 agosto 2011). Meno di un anno dopo è stata avviata, con la legge Fornero 28 giugno 2012 la riforma della materia che ha posto come regola generale, in tutti i casi in cui il giudice ritenga il motivo del licenziamento insufficiente, l’applicabilità di una sanzione di natura indennitaria; riforma poi rafforzata per tutti i nuovi rapporti di lavoro con il Jobs Act del 2015.
Nel decennio successivo entrambe queste leggi sono state sottoposte a diversi interventi correttivi ad opera del Legislatore e della Corte costituzionale. Ma la Corte stessa ha confermato la piena legittimità del suo nucleo centrale, ovvero del passaggio da un apparato sanzionatorio centrato sulla reintegrazione come regola generale, a uno centrato come regola generale sulla sanzione indennitaria.
*
Ecco, attraverso il mio confronto aperto con i giuslavoristi dell’ultima generazione questo libro di cui discutiamo oggi racconta non soltanto la mia esperienza parlamentare e universitaria personale – che interessa assai poco – ma soprattutto le vicende, i dibattiti, i passaggi-chiave in campo accademico come sul terreno sindacale e su quello politico-legislativo, attraverso i quali tutte queste trasformazioni del nostro ordinamento giuslavoristico sono potute avvenire.
Vi ringrazio dell’attenzione e ascolto con grande interesse gli interventi critici di tre profondi conoscitori dell diritto del lavoro – Maria Luisa Valauri, Vincenzo Nuvoli e Andrea Del Re – che hanno voluto leggere il libro per discuterne qui, ciò di cui sono loro molto grato.
