Un libro, che si legge d’un fiato, mette a fuoco la tragedia ucraina non soltanto nella sua cruda realtà attuale, ma in tutta la sua complessità storica, che affonda le radici nel tempo della Russia zarista, dell’Unione sovietica staliniana, dell’invasione nazi-fascista – Chi lo legge percepisce tutta l’atrocità del tradimento di Trump nei confronti di Kiev
.
Editoriale telegrafico per la Nwsl n. 600, 24 febbraio 2025 (terzo anniversario dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito di Putin), dedicato alla segnalazione del libro di Francesca Melandri, Piedi freddi (Bompiani, 2024, pp. 260, € 16,15) – In argomento ricordo l’editoriale telegrafico del sette novembre 2022, Per capire meglio come si costruisce la pace, con cui segnalai due libri (rispettivamente di Vittorio Emanuele Parsi e di Alessandro Maran) diversissimi da questo per genere letterario, ma intimamente legati a questo per ispirazione ideale
.
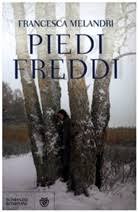 A tre anni dall’inizio dell’invasione sovietica dell’Ucraina, un libro bellissimo mette a fuoco questa tragedia non soltanto nella sua cruda realtà attuale, ma in tutta la sua complessità storica, che affonda le radici nel tempo della Russia zarista, in quello dell’Unione sovietica staliniana (la strage dei kulaki fu strage soprattutto di ucraini) e in quello della folle avventura nazi-fascista del 1942-43 (della quale l’Ucraina assai più che la Russia fu il vero teatro). È un vero e proprio libro di storia – pochissimo conosciuta – di questo Paese al centro del nostro continente, che aspira ad appartenere all’Occidente ma è considerato come terra propria dai nazionalisti russi, i quali al tempo stesso lo disprezzano. La cosa sorprendente è che il libro è scritto nella forma di “lettera aperta” di una figlia al padre che fece parte dell’Armir, la sciagurata “Armata italiana in Russia”: così che la Storia con la S maiuscola della dominazione zarista e di quella staliniana si intreccia con le memorie paterne della tragica rotta dell’esercito italiano nella sconfinata pianura che è oggi teatro dell'”operazione militare speciale” putiniana, come se tutto fosse l’effetto di un’unica spaventosa maledizione gravante su questo “cuore” dell’Europa. Solo leggendo Piedi freddi mi sembra di aver capito fino in fondo il dramma di questo popolo, la cui storia è la storia della Russia, ma che dalla Russia ha scelto di staccarsi per aggregarsi all’Unione Europea e per questo dalla stessa Russia viene crudelmente punito. Ed è leggendo questo libro – credo – che molti italiani insofferenti dell’impegno dell’UE a fianco dell’Ucraina si convinceranno della necessità di non desistere da questo impegno. Necessità divenuta oggi vitale a seguito del vero e proprio tradimento perpetrato ai danni dell’Ucraina dal neo-presidente degli U.S.A. Donald Trump: dal capo, cioè, di quello stesso Governo che nel 2014 fu il primo a cogliere il pericolo incombente di un salto di qualità nell’aggressione russa e a mobilitarsi per attrezzare l’Ucraina a resistere.
A tre anni dall’inizio dell’invasione sovietica dell’Ucraina, un libro bellissimo mette a fuoco questa tragedia non soltanto nella sua cruda realtà attuale, ma in tutta la sua complessità storica, che affonda le radici nel tempo della Russia zarista, in quello dell’Unione sovietica staliniana (la strage dei kulaki fu strage soprattutto di ucraini) e in quello della folle avventura nazi-fascista del 1942-43 (della quale l’Ucraina assai più che la Russia fu il vero teatro). È un vero e proprio libro di storia – pochissimo conosciuta – di questo Paese al centro del nostro continente, che aspira ad appartenere all’Occidente ma è considerato come terra propria dai nazionalisti russi, i quali al tempo stesso lo disprezzano. La cosa sorprendente è che il libro è scritto nella forma di “lettera aperta” di una figlia al padre che fece parte dell’Armir, la sciagurata “Armata italiana in Russia”: così che la Storia con la S maiuscola della dominazione zarista e di quella staliniana si intreccia con le memorie paterne della tragica rotta dell’esercito italiano nella sconfinata pianura che è oggi teatro dell'”operazione militare speciale” putiniana, come se tutto fosse l’effetto di un’unica spaventosa maledizione gravante su questo “cuore” dell’Europa. Solo leggendo Piedi freddi mi sembra di aver capito fino in fondo il dramma di questo popolo, la cui storia è la storia della Russia, ma che dalla Russia ha scelto di staccarsi per aggregarsi all’Unione Europea e per questo dalla stessa Russia viene crudelmente punito. Ed è leggendo questo libro – credo – che molti italiani insofferenti dell’impegno dell’UE a fianco dell’Ucraina si convinceranno della necessità di non desistere da questo impegno. Necessità divenuta oggi vitale a seguito del vero e proprio tradimento perpetrato ai danni dell’Ucraina dal neo-presidente degli U.S.A. Donald Trump: dal capo, cioè, di quello stesso Governo che nel 2014 fu il primo a cogliere il pericolo incombente di un salto di qualità nell’aggressione russa e a mobilitarsi per attrezzare l’Ucraina a resistere.
Due brani del libro
Io, noi conosciamo solo la pace. Ogni nostra attività da quando siamo nati, anche la più brutta, violenta, sgradevole, l’abbiamo svolta nel tempo di pace. Anche chi ha ucciso, ha ucciso in tempo di pace. Perfino chi è stato ucciso, è stato ucciso in tempo di pace. La donna ammazzata dal marito violento aveva la sua personale guerra in casa, ma fuori dall’uscio il mondo era in pace – e proprio questo l’ha condannata alla solitudine. Allora noi la guerra riusciamo a immaginarcela solo così, come una tra le mille attività del tempo di pace. Magari la più orrenda, certo, la più brutale, ma non poi tanto diversa dalle mille altre cose che possono succedere. Perfino noi che nei romanzi abbiamo descritto la guerra, siamo scrittori del tempo di pace.
E invece la guerra porta con sé un tempo diverso, dicono tutti coloro che hanno avuto la buia sorte di doverla conoscere. Un tempo in cui nemmeno il giro del sole è uguale a prima. Che io non l’abbia mai conosciuto è la più strabiliante delle fortune della mia vita di abitante dell’Europa dell’ovest negli ultimi ottant’anni, quella da cui sono dipese tutte le altre. Ma non la vedevamo, questa fortuna, come non vediamo l’aria che respiriamo fino a quando diventa nera di fumo. Eppure questa fortunata ignoranza è anche la nostra fragilità. Ora molte brave persone dicono: “Vogliamo solo la pace.” Ma mentre infuria una tempesta di neve, che senso ha dire “Vogliamo solo l’estate”?
[…]
I Mapuche abitavano quella che oggi chiamiamo Terra del fuoco. Lì vivevano da millenni, tra araucarie larghe come capanne e venti che piegano numinosi lo spazio come quelli nella tua steppa. Un giorno apparvero all’orizzonte cinque giganti fantastici di tela e di legno, che volavano silenziosi sull’onda lunga. Erano le navi di Magellano. Quando entrarono nella loro baia, i Mapuche non poterono non vederle – non erano ciechi. Ma nulla di ciò che sapevano del mondo, nulla di ciò che avevano conosciuto nella loro esistenza e che gli era stato tramandato dagli antenati, nulla di ciò che erano come individui e come società permetteva loro di attribuire un senso a ciò che stavano vedendo. I cinque velieri furono percepiti dai loro occhi, ma non dalle loro menti: quella era un’immagine impossibile, quindi non esisteva. Si narra così che i Mapuche voltarono la schiena a quella visione radicalmente incomprensibile, e proseguirono nelle loro faccende.
Ho l’impressione, papà, che per molti abitanti dell’Europa dell’Ovest questa nuova guerra in Ucraina sia come quei velieri per i Mapuche, altrettanto difficile da inserire nella loro cognizione non solo del mondo, ma soprattutto di sé. E così molti le voltano le spalle e si convincono che non ci sia.
Eppure dovrebbe essere semplice. C’è un paese che ne ha invaso un altro, in barba al diritto internazionale. C’è un paese che fa piovere missili e bombe sui condomini dall’altro. C’è un paese che deporta migliaia di abitanti dell’altro, che ne saccheggia i musei, che tortura, uccide e butta la gente dell’altro in fosse comuni, gli ruba le lavatrici, gli defeca sui letti e ne rapisce i bambini. Cosa c’è di difficile da capire? Dovrebbe essere facile scegliere da che parte stare. Soprattutto a noi Europei dell’Ovest a cui piace tanto sentirci nel giusto senza fare chissà quale sforzo. No, non dovrebbe essere complicato.
Ma in molti s’illudono che questo sia ancora il tempo di prima, quello in cui la guerra basta non volerla, anzi basta ripudiarla, ed essa cesserà. Certo, di guerre ne abbiamo viste e ne vediamo tante alla televisione, proviamo intensa pena per le loro vittime. Ne siamo straziati, così come deve essere, e giustamente chiediamo che ne siano fermati gli orrori. Ma sono altrove, e la pietà per l’altrove non ci ha mai costretto a metterci in discussione.
Questa guerra è diversa. Questa guerra ci obbligherebbe – se la guardassimo – a renderci conto che molti degli schemi con cui interpretavamo il mondo erano, a essere benevoli, incompleti. Per molti il rampicante del senso di sé è avviluppato intorno a un albero ormai mezzo secco. In realtà, anche se il tronco crollasse il rampicante potrebbe crescere altrove, e chi ci ha provato lo sa: non è impossibile cambiare idea, a farlo non si muore mica. Non è impossibile provare ad ascoltare punti di vista sulla storia d’Europa finora sconosciuti, come quello ucraino, o bielorusso, o estone. Potrebbe essere perfino liberatorio. Però molti si avvinghiano con ancora più determinazione al legno tarlato. Quasi che l’illuminata e umile fatica di rivedere opinioni obsolete sia appunto spaventosa quanto il morire.
Ci sono quelli che affermano “Non vogliamo la guerra!”, e considerano quest’affermazione il loro utile contributo alla pace. E poi ci sono quelli che hanno costruito l’intero senso di sé sull’opposizione alle guerre stupide e brutali dell’unico imperialismo piaga egemonica del mondo: quello americano.
C’è un problema, però. In Ucraina, chi ha mosso una guerra stupida e brutale non sono gli Usa.
È qualcun altro.
Che fare, quando i presupposti su cui per decenni si è costruito il senso di sé contrastano con i dati di realtà?
Im Kampf zwischen Dir und der Welt, sekundiere der Welt, diceva Kafka. Nella lotta tra te e il mondo, stai dalla parte del mondo. Ma sekundiere – assecondare – significa anche fare da secondo in un duello; ed ecco che con una sola parola il tuo omonimo Franz evoca da par suo un’intera scena grottesca e surreale: due duellanti intabarrati che in un’alba brumosa si preparano a spararsi a vicenda – Tu, e il Mondo. Con beffarda saggezza, Kafka suggerisce di sdoppiarci in un terzo personaggio, meno stolto e vanaglorioso, che veda quanto assurdo e ridicolo sia sfidare a duello il Mondo. E di offrirglisi quindi come alleato.
Ecco, papà: questo invito oggi è ignorato da tutti coloro che proprio non ci riescono a sekundieren una realtà in cui i morti in Ucraina non sono le ennesime vittime dell’egemonia Usa, bensì della Russia. Una realtà in cui se l’Ucraina fosse lasciata senz’armi per difendersi subirebbe in ogni città quello che ha subito a Buča, Mariupol’ e Izjum. Contro questa realtà oggi duellano le decennali definizioni di sé di molti Europei dell’Ovest: pacifista, antimperialista e soprattutto antiamericano. Verso questo senso di sé sono leali a oltranza, intendono proteggerlo a qualunque costo. E se questo significa porsi nella squadra avversaria a quella della realtà, si può sempre fare come i Mapuche.
