I motivi all’origine di questa iniziativa editoriale e una sintesi dei contenuti del libro, che ripercorre gli ultimi cinquant’anni dell’evoluzione della disciplina del mercato della manodopera
.
Scheda per la presentazione del volume, febbraio 2025 – Altri documenti e notizie in proposito nel portale dedicato al volume
.

La professoressa Luisa Riva Sanseverino con il suo primo allievo, Giuseppe Pera
Tra le ragioni della nascita di questo libro sta un divieto: quello che la mia Maestra, Luisa Riva Sanseverino, impose ai propri allievi chiedendo loro di non attivarsi, al momento del suo pensionamento, per la consueta sollecitazione ai colleghi affinché contribuissero con un loro scritto al Liber Amicorum per la illustre cattedratica pubblicato in occasione della sua ultima lezione. Lo stesso divieto impose ai propri il primo allievo di Luisa Riva Sanseverino, Giuseppe Pera, con cui ho collaborato strettamente per venticinque anni, il quale considerava la spesa per quella pubblicazione come uno spreco di denaro destinato alla ricerca, poiché il Liber Amicorum giova più che altro all’autocompiacimento del cattedratico cui è dedicato, ma non giova gran che al progresso culturale, contenendo scritti che per lo più sono già pubblicati anche altrove. Per gli stessi motivi, approssimandosi il giorno del mio pensionamento anch’io ho posto ai miei allievi quel divieto. Qualche tempo dopo la mia uscita dal ruolo, tuttavia, un gruppo di giovani giuslavoristi mi ha proposto un progetto diverso, che non mi risulta abbia dei precedenti, almeno in Italia: un’antologia di miei scritti relativamente brevi pubblicati nell’arco degli ultimi 50 anni, selezionati dai giovani colleghi secondo il criterio del maggiore impatto che gli scritti stessi possono avere avuto sull’evoluzione del diritto del lavoro, ciascuno accompagnato da un’ampia intervista dedicata a raccontare di ciascuno la storia, il contesto, il retroscena accademico e quello politico, ma anche a discutere dell’attualità o no della tesi sostenuta.
 Una iniziativa editoriale inedita – L’idea di ripercorrere mezzo secolo di evoluzione del diritto del lavoro, attraverso la rilettura critica e la discussione dei miei scritti che i trentenni e quarantenni di oggi ritengono avere maggiormente inciso su quell’evoluzione, in un primo tempo mi ha un po’ preoccupato: mi appariva un’impresa difficile e persino rischiosa. Poi però, considerato l’interesse e l’impegno dei giovani colleghi e in particolare di Francesco Alifano che accettava di accollarsi il ruolo non facile di coordinatore e curatore editoriale, mi sono convinto che il rischio meritasse di essere affrontato; e mi sono imbarcato nell’avventura.
Una iniziativa editoriale inedita – L’idea di ripercorrere mezzo secolo di evoluzione del diritto del lavoro, attraverso la rilettura critica e la discussione dei miei scritti che i trentenni e quarantenni di oggi ritengono avere maggiormente inciso su quell’evoluzione, in un primo tempo mi ha un po’ preoccupato: mi appariva un’impresa difficile e persino rischiosa. Poi però, considerato l’interesse e l’impegno dei giovani colleghi e in particolare di Francesco Alifano che accettava di accollarsi il ruolo non facile di coordinatore e curatore editoriale, mi sono convinto che il rischio meritasse di essere affrontato; e mi sono imbarcato nell’avventura.
Ne è nato questo libro dalla struttura del tutto inconsueta. Le prime duecento pagine ospitano quindici ampie interviste, ciascuna condotta – senza esclusione di colpi – da un giovane giuslavorista in riferimento a un mio articolo o saggio, che viene ripubblicato nella seconda parte del volume. Ogni intervista parte dal motivo di politica del lavoro che all’epoca mi spinse ad affrontare l’argomento, essendo tutta la mia attività giuslavoristica molto strettamente intrecciata con la mia attività di sindacalista negli anni ’70 e con la mia attività politica nei decenni successivi: a partire dalla battaglia per il superamento del monopolio statale del collocamento e dell’avviamento al lavoro “su richiesta numerica”, fino all’impegno in Senato per il Codice semplificato del lavoro e per la riforma dei licenziamenti del 2012-2015 nella XVI e nella XVII legislatura.
A chi serve il diritto del lavoro – La prima intervista, riferita al saggio di mio fratello Andrea e mio che reca questo titolo, del 1994, è dedicata alla questione circa le categorie di lavoratori che dalle regole vigenti sono effettivamente protette e quelle che possono invece esserne danneggiate. Dove a ben vedere la risposta è di competenza esclusiva del giuslavorista solo in seconda battuta, in sede di valutazione delle norme ordinarie alla luce dei principi costituzionali, mentre in prima battuta essa può scaturire soltanto dal dialogo tra giuslavorista ed economista del lavoro: è compito di quest’ultimo, infatti, accertare se in un determinato contesto l’assetto del mercato del lavoro corrisponde in concreto di più al modello fondato sul conflitto di interessi tra insider e outsider, oppure al modello dell’interesse condiviso tra insider e outsider. Questo capitolo iniziale sottolinea dunque l’esigenza del dialogo stretto fra giuslavorista ed economista del lavoro, che è poi il filo conduttore di tutto il libro.
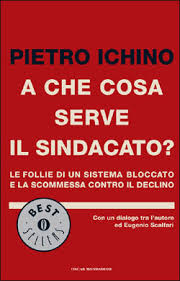 A che cosa serve il sindacato – Quest’altro è invece il tema di un mio libro del 2005, cui è dedicata la seconda intervista. In quel libro sottoponevo a una critica serrata il regime di rigida inderogabilità della disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di settore, sostenendo – anche con lo studio approfondito di due case studies – che quel regime fosse di ostacolo all’afflusso degli investimenti stranieri e in particolare della candidatura dell’Italia a ospitare nuovi insediamenti aziendali caratterizzati da piani industriali innovativi e forme di organizzazione del lavoro non riconducibili agli schemi codificati nei contratti collettivi nazionali. Solo cinque anni dopo esplose la crisi della Fiat che Sergio Marchionne si propose di risolvere con un piano industriale industriale fortemente innovativo che prevedeva tre deroghe al contratto nazionale. La Fiom vi si oppose con veemenza, ma alla fine quella linea passò e venne poi codificata, nel 2011, con un accordo interconfederale che prevedeva la derogabilità del contratto nazionale ad opera di quello aziendale su tutte la materie, con la sola esclusione dei minimi retributivi tabellari. Donde la mia tesi, che mi sembra abbia trovato piena conferma in quella, come in molte altre vicende aziendali, secondo cui il mestiere più importante che il sindacato può e deve svolgere consiste nell’essere l’intelligenza collettiva che guida i lavoratori di un’azienda nella valutazione del piano industriale innovativo, della qualità tecnica ed etica dell’imprenditore che lo propone; e, se la valutazione è positiva, nel guidare i lavoratori in una scommessa comune con l’imprenditore stesso su quel piano, riservandosi poi il compito di controllarne l’implementazione e la corretta distribuzione dei frutti una volta che la scommessa sia stata vinta.
A che cosa serve il sindacato – Quest’altro è invece il tema di un mio libro del 2005, cui è dedicata la seconda intervista. In quel libro sottoponevo a una critica serrata il regime di rigida inderogabilità della disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di settore, sostenendo – anche con lo studio approfondito di due case studies – che quel regime fosse di ostacolo all’afflusso degli investimenti stranieri e in particolare della candidatura dell’Italia a ospitare nuovi insediamenti aziendali caratterizzati da piani industriali innovativi e forme di organizzazione del lavoro non riconducibili agli schemi codificati nei contratti collettivi nazionali. Solo cinque anni dopo esplose la crisi della Fiat che Sergio Marchionne si propose di risolvere con un piano industriale industriale fortemente innovativo che prevedeva tre deroghe al contratto nazionale. La Fiom vi si oppose con veemenza, ma alla fine quella linea passò e venne poi codificata, nel 2011, con un accordo interconfederale che prevedeva la derogabilità del contratto nazionale ad opera di quello aziendale su tutte la materie, con la sola esclusione dei minimi retributivi tabellari. Donde la mia tesi, che mi sembra abbia trovato piena conferma in quella, come in molte altre vicende aziendali, secondo cui il mestiere più importante che il sindacato può e deve svolgere consiste nell’essere l’intelligenza collettiva che guida i lavoratori di un’azienda nella valutazione del piano industriale innovativo, della qualità tecnica ed etica dell’imprenditore che lo propone; e, se la valutazione è positiva, nel guidare i lavoratori in una scommessa comune con l’imprenditore stesso su quel piano, riservandosi poi il compito di controllarne l’implementazione e la corretta distribuzione dei frutti una volta che la scommessa sia stata vinta.
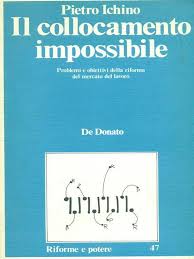 L’abrogazione del monopolio statale del collocamento – È questa un’altra vicenda del nostro ordinamento del lavoro che molti giovani, persino tra i giuslavoristi, ignorano. Pochi sanno, infatti, che fino agli anni ’90 in Italia una regola generale vietava a datori e prestatori di lavoro di scegliersi a vicenda, imponendo che l’incontro avvenisse nel rispetto di graduatorie pubbliche tra i disoccupati gestite dagli uffici di collocamento (i quali, ciononostante, riuscivano a intermediare soltanto l’uno o il due per cento degli incontri fra domanda e offerta di manodopera). Quel regime, contro il quale condussi una ventennale battaglia solitaria, venne finalmente abrogato, anche per merito di una sentenza della Corte di Giustizia europea del 1997 in un giudizio in cui fui parte attiva contro il Governo italiano. Caduto quel regime, però, l’Italia ha tardato molto (al punto che, salvo limitate eccezioni, non è ancora arrivata) a dotarsi di un sistema efficiente e moderno di servizi al mercato del lavoro. Sono questi i temi di altri due scritti selezionati dai miei giovani interlocutori e di altrettante corpose interviste, che ripercorrono l’intera vicenda di questo “giallo” storico-giuridico-politico tutto italiano.
L’abrogazione del monopolio statale del collocamento – È questa un’altra vicenda del nostro ordinamento del lavoro che molti giovani, persino tra i giuslavoristi, ignorano. Pochi sanno, infatti, che fino agli anni ’90 in Italia una regola generale vietava a datori e prestatori di lavoro di scegliersi a vicenda, imponendo che l’incontro avvenisse nel rispetto di graduatorie pubbliche tra i disoccupati gestite dagli uffici di collocamento (i quali, ciononostante, riuscivano a intermediare soltanto l’uno o il due per cento degli incontri fra domanda e offerta di manodopera). Quel regime, contro il quale condussi una ventennale battaglia solitaria, venne finalmente abrogato, anche per merito di una sentenza della Corte di Giustizia europea del 1997 in un giudizio in cui fui parte attiva contro il Governo italiano. Caduto quel regime, però, l’Italia ha tardato molto (al punto che, salvo limitate eccezioni, non è ancora arrivata) a dotarsi di un sistema efficiente e moderno di servizi al mercato del lavoro. Sono questi i temi di altri due scritti selezionati dai miei giovani interlocutori e di altrettante corpose interviste, che ripercorrono l’intera vicenda di questo “giallo” storico-giuridico-politico tutto italiano.
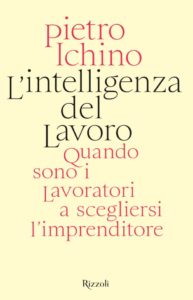 Il rovesciamento del paradigma del mercato del lavoro – Il ritardo italiano rispetto agli altri Paesi europei sul terreno dei servizi al mercato del lavoro è tanto più dannoso, quanto più va delineandosi un mutamento epocale della struttura e del modo di funzionare del mercato del lavoro nell’Occidente sviluppato: da una situazione di monopsonio strutturale, quale quella che caratterizzava questo mercato all’indomani della prima rivoluzione industriale, con l’impresa manifatturiera “cattedrale nel deserto” a fronte di un immenso esercito di disoccupati o sottoccupati agricoli, si è passati nel secolo attuale a una situazione di cronica e diffusissima carenza di offerta di manodopera rispetto alla domanda espressa dal tessuto produttivo. Oggi il mercato del lavoro non è più un luogo dove è soltanto l’imprenditore a scegliersi i collaboratori, perché sono sempre più diffusamente anche le persone che vivono del proprio lavoro a scegliere l’impresa più capace di valorizzarlo. Le due interviste riferite ad altrettanti miei scritti su questi temi discutono di questo rovesciamento del paradigma e del suo impatto rilevantissimo sulla ragion d’essere stessa del diritto del lavoro e sulle tecniche di protezione del lavoro, che richiedono un profondo aggiornamento rispetto alle tecniche dominanti nel XX secolo.
Il rovesciamento del paradigma del mercato del lavoro – Il ritardo italiano rispetto agli altri Paesi europei sul terreno dei servizi al mercato del lavoro è tanto più dannoso, quanto più va delineandosi un mutamento epocale della struttura e del modo di funzionare del mercato del lavoro nell’Occidente sviluppato: da una situazione di monopsonio strutturale, quale quella che caratterizzava questo mercato all’indomani della prima rivoluzione industriale, con l’impresa manifatturiera “cattedrale nel deserto” a fronte di un immenso esercito di disoccupati o sottoccupati agricoli, si è passati nel secolo attuale a una situazione di cronica e diffusissima carenza di offerta di manodopera rispetto alla domanda espressa dal tessuto produttivo. Oggi il mercato del lavoro non è più un luogo dove è soltanto l’imprenditore a scegliersi i collaboratori, perché sono sempre più diffusamente anche le persone che vivono del proprio lavoro a scegliere l’impresa più capace di valorizzarlo. Le due interviste riferite ad altrettanti miei scritti su questi temi discutono di questo rovesciamento del paradigma e del suo impatto rilevantissimo sulla ragion d’essere stessa del diritto del lavoro e sulle tecniche di protezione del lavoro, che richiedono un profondo aggiornamento rispetto alle tecniche dominanti nel XX secolo.
È in questo contesto che le politiche attive del lavoro assumono un ruolo cruciale. Ed è in questo stesso contesto che assumono un rilievo inedito anche i temi trattati nelle altre interviste contenute nel libro: da quello dell’autonomia negoziale individuale, troppo a lungo disconosciuta dai giuslavoristi, a quello del tempo della prestazione lavorativa, sul quale più che su altri l’ordinamento riconosce sempre maggiore spazio all’autonomia individuale; dal fenomeno della segmentazione dell’impresa e dei suoi riflessi sulle relazioni di lavoro a un nuovo approccio multidisciplinare, giuridico-economico, alla definizione del giustificato motivo di licenziamento.
