Le contraddizioni e le lacune delle definizioni dominanti in giurisprudenza e dottrina circa le “ragioni economiche e organizzative” del recesso legittimo dell’imprendditore – Il modo in cui la microeconomia consente al diritto del lavoro di affinare la nozione e di evitare gli scogli nei quali l’orientamento tradizionale si è incagliato
.
Intervista-discussione a cura di Michele Dalla Sega, che è stata pubblicata sul Bollettino Adapt il 27 maggio 2024 – L’intervista è parte di una serie dedicata a una rivisitazione dei miei scritti pubblicati nell’arco degli ultimi 50 anni; questa prende spunto dal mio intervento al convegno nazionale dell’AIDLaSS di Venezia del maggio 2007, pubblicato sulla rivista Argomenti di Diritto del Lavoro 2007, n. 4/5, pp. 884-889, sotto il titolo Le questioni aperte in materia di licenziamento per motivo oggettivo – L’ultima intervista precedente della stessa serie messa online su questo sito è dedicata al tema de La segmentazione dell’impresa e l’interposizione nelle prestazioni di lavoro
.
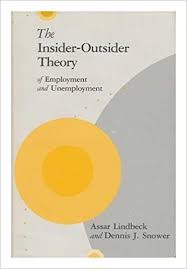 D.: Della necessità di una riforma della materia dei licenziamenti hai incominciato a discutere e scrivere nella prima metà degli anni ’90; poi a questo tema hai dedicato un capitolo nel libro Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne, del 1996, per tornare in seguito sull’argomento in modo ancora più ampio nel terzo volume del trattato sul contratto di lavoro, del 2003, e riprenderlo nell’intervento al convegno dell’AIDLaSS 2007 qui riprodotto. In quello stesso torno di tempo hai incominciato a proporre un’apertura del diritto del lavoro al contributo che può venirgli dalla scienza economica: è difficile non vedere un nesso tra queste due tappe della tua produzione giuslavoristica. I tuoi contraddittori, infatti, imputano proprio all’approccio di labour law and economics la responsabilità delle tue teorie eversive della tutela forte della stabilità del posto di lavoro, che fino a quindici anni fa ha caratterizzato l’ordinamento italiano. Che cosa rispondi a questa contestazione?
D.: Della necessità di una riforma della materia dei licenziamenti hai incominciato a discutere e scrivere nella prima metà degli anni ’90; poi a questo tema hai dedicato un capitolo nel libro Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne, del 1996, per tornare in seguito sull’argomento in modo ancora più ampio nel terzo volume del trattato sul contratto di lavoro, del 2003, e riprenderlo nell’intervento al convegno dell’AIDLaSS 2007 qui riprodotto. In quello stesso torno di tempo hai incominciato a proporre un’apertura del diritto del lavoro al contributo che può venirgli dalla scienza economica: è difficile non vedere un nesso tra queste due tappe della tua produzione giuslavoristica. I tuoi contraddittori, infatti, imputano proprio all’approccio di labour law and economics la responsabilità delle tue teorie eversive della tutela forte della stabilità del posto di lavoro, che fino a quindici anni fa ha caratterizzato l’ordinamento italiano. Che cosa rispondi a questa contestazione?
R.: La mia convinzione che la disciplina italiana della stabilità del posto di lavoro soffrisse di alcuni difetti molto gravi era nata già negli anni ’80, soprattutto dal confronto con le discipline vigenti negli altri grandi Paesi dell’Occidente sviluppato: il nostro regime applicabile alle aziende grandi e medie costituiva un caso del tutto isolato per la sua peculiarità, costituita dalla sanzione della reintegrazione automatica, sommata a un risarcimento di entità mediamente molto elevata. Il cumulo delle due sanzioni, la cui entità poteva aumentare in modo abnorme in proporzione alla durata del procedimento giudiziale, aveva l’effetto di equiparare, o quasi, il regime di stabilità del dipendente privato a quello del dipendente pubblico, cioè a un regime di sostanziale job property. Detto questo, è vero però che incominciai a guardare alla questione con maggiore attenzione e con occhio più critico dopo essermi imbattuto nella Insider/Outsider Theory di Assar Lindbeck e Dennis J. Snower, che in Italia incominciò a essere diffusamente conosciuta nel corso degli anni ’80.
D.: Posso chiederti di esporre in sintesi quella teoria?
R.: Secondo il modello proposto dai due economisti citati, la disciplina della stabilità costituisce essenzialmente una protezione dei lavoratori dipendenti regolari contro la concorrenza, attuale o potenziale, dei disoccupati, dei new entrants e degli irregolari. Quel modello, che ovviamente non spiega tutta la realtà del mercato e del diritto del lavoro, ma ne evidenzia pur sempre un aspetto rilevantissimo, mostra l’improponibilità dell’idea che la job property costituisca un “diritto fondamentale della persona”. Tra il 1970 e il 2012, infatti, da quel preteso diritto fondamentale è stata esclusa circa metà degli appartenenti alla forza-lavoro italiana; e quel diritto poteva essere assicurato ai dipendenti “di ruolo” delle imprese medio-grandi proprio al prezzo di scaricare sull’altra metà della forza-lavoro, occupata nelle piccole imprese appaltatrici di servizi o terziste, tutto il peso della flessibilità di cui il sistema aveva bisogno. Inoltre, fin dagli anni ’70 e ’80 appariva evidente la contraddizione tra il principio di insindacabilità delle scelte imprenditoriali, sempre ritualmente ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, e la sovrapposizione del controllo giudiziale alle scelte gestionali sottese ai licenziamenti per motivo oggettivo, evidentissima nella giurisprudenza dei giudici di merito.
D.: Secondo l’orientamento dottrinale dominante, però, il compito del giudice è limitato alla verifica dell’effettività della scelta compiuta dall’imprenditore.
R.: Questa che hai enunciato è la lettura del principio del giustificato motivo oggettivo di licenziamento che Giuseppe Pera propose – come l’unica compatibile con il principio costituzionale dell’insindacabilità delle scelte gestionali dell’imprenditore – nel corso del convegno dell’AIDLaSS svoltosi nel 1968 a Firenze (atti Giuffrè, 1969) e che era stata ripresa da Luca Nogler nella sua relazione introduttiva al convegno della stessa associazione svoltosi nel 2007 a Venezia. Lo stesso Giuseppe Pera, però, all’indomani dell’entrata in vigore della nuova disciplina dei licenziamenti avvertiva che, se al principio del giustificato motivo oggettivo deve essere attribuito questo significato, non ne consegue alcuna apprezzabile limitazione della facoltà di recesso del datore di lavoro, dovendosi considerare già vietato da altre norme il recesso dettato da motivi illeciti. Il fatto è che l’orientamento giurisprudenziale destinato a prevalere largamente fin dai primi anni ’70 non fu affatto coerente con quella proposta interpretativa: al contrario, esso si caratterizzò per un controllo penetrante sul merito della scelta imprenditoriale sottesa al licenziamento e dunque per la sovrapposizione a questa scelta di quella ritenuta corretta dal giudice. Come mi sono proposto di mostrare nel capitolo del trattato sul Contratto di lavoro dedicato a questa materia (§ 516), ogni volta che una sentenza decide se il licenziamento è motivato dalla soppressione del posto di lavoro o dalla sostituzione della persona interessata, quella sentenza entra di fatto nel merito della scelta imprenditoriale (perché implica una valutazione circa la fungibilità effettiva tra la persona licenziata e quella contestualmente assunta); lo stesso accade ogni volta che una sentenza decide se sarebbe stato praticabile o no il repêchage della persona licenziata in una diversa posizione lavorativa in seno all’azienda. Un controllo giudiziale sul merito della scelta imprenditoriale viene evidentemente esercitato, poi, anche con la sentenza che decide circa la fungibilità o no tra due persone ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta di quella che dovrà essere licenziata per riduzione dell’organico. Insomma, tra il modo in cui viene di fatto comunemente applicata la regola del giustificato motivo di licenziamento e il principio della insindacabilità delle scelte imprenditoriali si è determinata subito, fin dai primi anni ’70, una fortissima tensione.
D.: Perché ritieni che questa contraddizione possa essere, invece, superata facendo ricorso alla nozione, tratta dalla microeconomia, di “contenuto assicurativo del rapporto di lavoro”?
R.: Perché vedo due conseguenze logiche molto importanti nell’idea che il contratto di lavoro sostanzialmente contenga una sorta di “polizza assicurativa”, in virtù della quale si addossa all’imprenditore, entro un certo limite, il rischio di perdita derivante dalla prosecuzione del rapporto. Per un verso questa impostazione teorica consente di limitare il potere di recesso dell’imprenditore ai soli casi in cui la perdita attesa superi una determinata soglia: si recupera, così, la valenza protettiva della disciplina dei licenziamenti, che l’interpretazione proposta da Giuseppe Pera nel 1968 e riproposta da Luca Nogler nel 2007 di fatto azzerava o quasi. Per altro verso questa costruzione consente di rispettare il principio di insindacabilità della gestione aziendale, perché il giudice non si ingerisce più nelle scelte di gestione aziendale, ma si limita a verificare che la perdita effettivamente attesa dall’imprenditore, come conseguenza della prosecuzione del rapporto, sia superiore a una certa soglia che il giudice stesso ritiene costituisca il limite massimo della perdita ragionevolmente accollabile all’impresa, ovvero per così dire il “massimale di copertura” offerto dalla “polizza assicurativa” implicita nel contratto.
D.: Nel trattato del 2003, però, hai rilevato un’altra contraddizione logica, che nasce proprio dalla definizione del giustificato motivo oggettivo in termini di “perdita attesa” come conseguenza della prosecuzione del rapporto: se il g.m.o. è qualche cosa che si colloca nel futuro, esso non può essere dimostrato né documentalmente né tanto meno a mezzo di testimoni.
R.: È così, ne sono convinto. Il g.m.o. è la ragionevole previsione che il rapporto di lavoro genererà una perdita rilevante; e le previsioni, per quanto ragionevoli, non sono suscettibili di dimostrazione in un procedimento giudiziale. Proprio per questo motivo nel trattato del 2003 e poi di nuovo nel convegno di Venezia del 2007 ho sostenuto che il solo modo per accertare che la perdita effettivamente attesa dall’imprenditore superi la soglia, ovvero il “massimale coperto dalla polizza assicurativa”, consiste nel verificare la sua disponibilità a transigere corrispondendo alla persona licenziata un importo corrispondente a quella soglia. Ma già in quell’intervento del 2007 osservavo che lo medesimo vaglio quantitativo circa la perdita attesa dall’imprenditore si applica automaticamente in tutti i casi in cui è la legge stessa a stabilire l’entità della soglia, imponendo un indennizzo in favore della persona licenziata. E indicavo l’entità dell’indennizzo che mi pareva ragionevole stabilire, assumendo come parametro la somma del risarcimento e dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, che era allora prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori: all’incirca due annualità dell’ultima retribuzione.
 D.: Era la proposta de iure condendo che avevi già argomentato dieci anni prima ne Il lavoro e il mercato. Come era stata accolta, allora, quella proposta dai tuoi colleghi?
D.: Era la proposta de iure condendo che avevi già argomentato dieci anni prima ne Il lavoro e il mercato. Come era stata accolta, allora, quella proposta dai tuoi colleghi?
R.: Da alcuni favorevolmente: ricordo in particolare i commenti di Giuseppe Pera e di Raffaele De Luca Tamajo. Anche alcuni giuslavoristi della mia generazione come Marco Biagi, Arturo Maresca e Riccardo Del Punta pensavano che, almeno a grandi linee, fosse quella la strada da battere. Nel 1997 il senatore Franco Debenedetti, appartenente al gruppo dei Democratici di Sinistra, si spinse addirittura a presentare un disegno di legge modellato su quella proposta; e il segretario del P.D.S. Massimo D’Alema la menzionò al congresso della Cgil, in polemica con le chiusure del segretario generale della stessa Confederazione. Ma per la maggioranza dei giuslavoristi e dell’opinione pubblica, non solo di sinistra, i tempi non erano maturi per il superamento del regime della job property nelle imprese medio-grandi. Anche se in concreto questa era garantita solo a metà della popolazione interessata: il che avrebbe dovuto far riflettere sull’impossibilità di considerarla come un diritto fondamentale della persona.
D.: Sta di fatto che solo pochi anni più tardi è arrivata la riforma Fornero, e poco dopo il Jobs Act: due leggi che hanno portato a un vero e proprio cambio di paradigma nella disciplina dei licenziamenti. Era la realizzazione di quanto avevi proposto?
R.: Una realizzazione a tappe, tormentata anche a causa di diversi interventi correttivi succedutisi nel tempo, che ha portato a una disciplina legislativa davvero un po’ troppo frammentata e di difficile lettura. Però alla fine l’idea che la sanzione indennitaria sia la regola generale e la sanzione reintegratoria l’eccezione è passata. Il fatto è che per arrivarci è stato necessario che l’Italia si trovasse sull’orlo di una catastrofe economico-finanziaria e che questa riforma venisse raccomandata al nostro Governo – come è accaduto il 5 agosto 2011 – congiuntamente dal Governatore uscente e dal Governatore entrante della Banca Centrale Europea. Fu quella lettera a indurre il Governo Berlusconi, nel settembre 2011, nella fase culminante della crisi economico-finanziaria, a fare proprio almeno a parole il mio progetto del “codice semplificato del lavoro” – oggetto dei disegni di legge n. S-1872 e S-1873, firmati da 52 senatori dell’opposizione – in cui era contenuta anche la riforma della materia dei licenziamenti. Ma quel Governo era ormai arrivato al capolinea e dovette passare il testimone al Governo Monti.
D.: Perché alla B.C.E. interessava la riforma dei licenziamenti nel nostro Paese?
R.: Nella lettera del 5 agosto 2011 la B.C.E. non ci ha raccomandato soltanto di armonizzare la nostra disciplina di questa materia con quella degli altri Paesi dell’Unione, ma anche di investire di più sulle misure di sostegno alle persone che perdono un’occupazione e ne cercano un’altra. Questo aiuta il rafforzamento del sistema economico innanzitutto perché l’armonizzazione dell’ordinamento del lavoro rispetto al resto dell’UE favorisce l’afflusso degli investimenti esteri; inoltre perché la maggiore fluidità del mercato del lavoro favorisce il passaggio delle persone dalle aziende marginali a quelle più capaci di valorizzarne il lavoro, producendo così un effetto positivo sulla produttività del lavoro stesso. Sostenere economicamente e assistere la mobilità delle persone ha dunque un effetto positivo anche sulle loro retribuzioni. Per questo è pure necessario un sistema della contrattazione collettiva più capace di incentivare e premiare gli aumenti di produttività, dunque un sistema che attribuisca un ruolo più rilevante alla contrattazione aziendale: nell’estate del 2011, infatti, la B.C.E. ci sollecitò anche a favorire lo spostamento del baricentro del sistema delle relazioni industriali verso la periferia. D’altra parte, la stessa Banca centrale aveva pieno titolo per chiederci queste misure di rafforzamento del nostro sistema economico, dal momento che essa si stava mobilitando in modo massiccio per l’acquisto dei titoli del nostro debito pubblico, indispensabile per salvare l’Italia dal rischio gravissimo di default. La stessa raccomandazione, poi, seppure non in forma pubblica, è stata rivolta dalla B.C.E. al Governo Renzi nell’estate del 2014.
D.: Vuoi dire che fu la crisi finanziaria, più che una maturazione dell’opinione pubblica e della cultura del lavoro, a consentire l’armonizzazione della nostra disciplina dei licenziamenti rispetto agli altri Paesi della UE?
R.: Guardando a quello che è accaduto in quegli anni con il dovuto distacco, la metterei così: senza la gravissima crisi del debito pubblico del 2011, probabilmente, il processo di maturazione politico-culturale necessario per arrivare alla riforma sarebbe stato più lungo; però il dibattito intorno al mio progetto ha fatto sì che, nel momento in cui la svolta è stata imposta dalla catastrofe imminente della finanza pubblica, il Governo e il Parlamento avessero gli attrezzi tecnici necessari e fossero culturalmente preparati a compierla. Poi il percorso legislativo della riforma è stato più tormentato del previsto e ha portato a un risultato non del tutto corrispondente a quanto avevo proposto; però mi sembra che, almeno per i rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015, possa considerarsi compiutamente recepito il contenuto essenziale del mio progetto, ovvero il passaggio da un regime sostanzialmente fondato su di una property rule – la reintegrazione nel posto di lavoro come regola generale – a un regime fondato su di una liability rule: la regola generale, adesso, è la condanna al solo indennizzo.
D.: Negli anni successivi, tuttavia, il nuovo quadro di regole è stato messo in discussione dai diversi interventi della Corte Costituzionale. Quale effetto hanno avuto questi interventi sull’impianto delle ultime due riforme e, soprattutto, sulla teoria del “contenuto assicurativo del rapporto di lavoro” che tu proponi?
R.: Le modifiche principali che sono state apportate alla disciplina dei licenziamenti contenuta nel d.lgs. n. 23/2015 sono costituite dall’aumento dell’indennizzo massimo da 24 a 36 mensilità dell’ultima retribuzione, disposto dal decreto-legge n. 87/2018, e dalla soppressione dell’automatismo originariamente previsto per la determinazione dell’indennizzo in relazione all’anzianità di servizio della persona interessata, disposta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 194/2018: ora la determinazione dell’indennizzo tra il minimo e il massimo rientra nella piena discrezionalità del giudice. Né l’intervento del legislatore né quello della Consulta, dunque, hanno intaccato la parte essenziale della riforma, consistente nel passaggio – per il caso di licenziamento ritenuto dal giudice non sufficientemente motivato – dalla property rule alla liability rule.
D.: Questo passaggio continua comunque a essere tema di scontro. Basti pensare ai quesiti referendari depositati dalla Cgil il 12 aprile 2024, che puntano, da una parte, a cancellare il tetto massimo all’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo per le aziende sotto i 15 dipendenti, dall’altra all’abrogazione secca del d.lgs. n. 23/2015, che ha introdotto il “contratto di lavoro a tutele crescenti”. È anche questo il segno di una costante insofferenza verso l’ingresso delle ragioni dell’economia nell’ambito delle regole giuslavoristiche?
R.: Non la metterei in questi termini, perché sono ragionevolmente proponibili anche dei ragionamenti di natura economica a sostegno del principio enunciato dalla Cgil, secondo cui “lo Statuto dei lavoratori non si tocca”: diversi economisti di orientamento istituzionalista – qui in Italia, per esempio, Lorenzo Sacconi – sostengono che il regime di protezione rigida della stabilità del posto favorisce l’investimento delle imprese e dei loro dipendenti sulla formazione di questi ultimi. Quello che mi sembra scorretto è argomentare a sostegno dell’abrogazione del d.lgs. n. 23/2015 presentando, come ha fatto il leader della Cgil Landini all’avvio dell’iniziativa referendaria, il Jobs Act come un “fattore di precarizzazione del lavoro”: nell’ultimo quindicennio la probabilità di essere licenziati è rimasta invariata; invece i rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono aumentati sia in valore assoluto sia in percentuale rispetto alla forza-lavoro complessiva, e i contratti a termine – in termini di stock – sono rimasti circa un sesto rispetto al totale, in linea con la media UE. Per altro verso, l’armonizzazione della nostra disciplina dei licenziamenti rispetto al resto dell’UE è necessaria per favorire l’afflusso degli investimenti esteri, dei quali l’Italia ha grande bisogno se vuole promuovere l’aumento della produttività del lavoro, quindi anche delle retribuzioni. La riforma dei licenziamenti, poi, ha più che dimezzato il contenzioso giudiziale su questa materia, eliminando un’anomalia tutta italiana: la situazione precedente, nella quale a ogni licenziamento faceva seguito un ricorso al giudice, non giovava certo ai lavoratori, ma solo al ceto forense, che infatti mi rimprovera duramente la responsabilità per la drastuca riduzione della domanda di assistenza legale in tema di cessazione del rapporto di lavoro. Detto questo, su una cosa do ragione alla Cgil.
 D.: A che cosa ti riferisci?
D.: A che cosa ti riferisci?
R.: L’assetto della disciplina della materia dei licenziamenti, anche in conseguenza degli interventi legislativi e della Corte costituzionale susseguitisi dal 2018, è oggi troppo segmentato e di difficile lettura. La stessa Corte costituzionale ha sollecitato il legislatore a un intervento di semplificazione e razionalizzazione di questa disciplina.
D.: Quali potrebbero essere, secondo te, le linee portanti di un intervento di questo genere?
R.: Sulla base di un approccio pragmatico, una riscrittura auspicabile potrebbe: a) per il licenziamento determinato da motivi illeciti confermare la sanzione reintegratoria; b) per il licenziamento disciplinare attribuire al giudice – quando ritenga il motivo addotto non sufficiente – la scelta discrezionale tra la sanzione reintegratoria e quella indennitaria: dettare, cioè, una disciplina sostanzialmente corrispondente a quanto di fatto accade nei tribunali di tutta Italia oggi, anche se in contrasto con quanto la disciplina legislativa vigente prevede; c) per i licenziamenti economici, individuali o collettivi estendere a tutti la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 23/2015, cioè la sanzione esclusivamente indennitaria; d) per il licenziamento nelle imprese fino a 15 dipendenti aumentare l’entità massima dell’indennizzo da 6 a 12 o 18 mensilità per le imprese con fatturato superiore a determinate soglie, anche qui recependo l’indicazione contenuta in una sentenza della Corte costituzionale. Sono convinto che una riforma così concepita avrebbe il voto favorevole di una maggioranza parlamentare molto larga e che essa verrebbe ritenuta dalla Corte di Cassazione idonea a evitare il referendum, perché configurerebbe un mutamento sostanziale della disciplina vigente nella direzione indicata dal referendum sulle materie b) e d), oltre che per il fatto di conseguire una unificazione dei regimi. Ma se anche, invece, la Cassazione non la ritenesse idonea a evitare il referendum e ne spostasse il quesito sulla nuova legge, sarebbe molto più facile mobilitare l’elettorato in difesa di questa disciplina, comprensibile da chiunque anche senza la consulenza dell’avvocato.
D.: La prima legge sui licenziamenti individuali, che introdusse la regola del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ossia la l. n. 604/1966, arrivava dopo anni in cui della materia si erano occupate le parti sociali, attraverso i vari accordi interconfederali che introducevano alcune limitazioni al potere di licenziamento. Che ruolo può giocare invece oggi, in un quadro normativo completamente differente, l’autonomia collettiva per mantenere un protagonismo delle parti sociali sulla materia?
R.: Mi sembra difficile che la contrattazione collettiva possa oggi tornare a rivendicare la propria competenza sulla materia della limitazione della facoltà di recesso del datore di lavoro, riproponendo, a mezzo secolo di distanza, lo slogan della Cisl anni ’60: “il nostro statuto è il contratto”. Vedo invece la possibilità che la contrattazione collettiva intervenga per assicurare ai lavoratori a carico dell’imprenditore, nel caso di licenziamento per motivi economico-organizzativi, una integrazione del trattamento di disoccupazione ed eventualmente anche l’attivazione di un servizio assistenza nella ricerca della nuova occupazione (c.d. outplacement). Resta il fatto che oggi è di molte volte più frequente il caso del recesso del prestatore rispetto al caso inverso; e questo è un fatto positivo, che conferma una capacità diffusa dei lavoratori di “usare il mercato”, traendo forza negoziale dalla propria capacità effettiva di scelta. La contrattazione collettiva dovrebbe occuparsi della tendenza, che si sta effettivamente registrando, a un ricorso eccessivo delle imprese a clausole restrittive della facoltà di recesso del dipendente, e non solo sotto forma di patto di non concorrenza. Ma questo è un altro discorso.
D.: Il passaggio dalla property rule alla liability rule dovrebbe portare a garantire al lavoratore, come hai ribadito in varie occasioni, la necessaria sicurezza economica e professionale nel caso di perdita del posto. Eppure, sul primo fronte assistiamo a costanti interventi sulla materia delle politiche passive, di cui si fatica a individuare la ratio. Quanto alla sicurezza “professionale”, invece, parliamo costantemente (come ci ricordi anche nel saggio Appunti per un rilancio delle politiche attive del lavoro) degli storici ritardi e della necessità di rilancio delle politiche attive. Flessibilizzare in uscita il mercato del lavoro senza intervenire strutturalmente su questi aspetti non rischia di essere una riforma “a metà”?
R.: La riforma del 2015 è stata accompagnata da un rilevante aumento dell’entità, della durata e del campo di applicazione del trattamento di disoccupazione, che in forma ridotta è stato esteso anche ai collaboratori continuativi autonomi: questo ampliamento dell’area di applicazione e rafforzamento quantitativo del sostegno del reddito delle persone che perdono il posto, disposto dal d.lgs. n. 22/2015, non può essere dimenticato quando si discute degli effetti del Jobs Act. Vero è che è rimasta, invece, quasi del tutto inattuata la parte di quel decreto relativa alle politiche attive e in particolare al “contratto (o assegno) di ricollocazione”. Di questo ho discusso con Lilli Casano e Silvia Spattini nell’intervista dedicata a questo importantissimo capitolo della nostra materia.
D.: Nel saggio operi poi alcuni cenni all’esperienza comparata, citando i casi di Germania, Francia e Spagna. Paesi che, nel 2007, erano già in possesso di strutturati meccanismi di indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato. Che traiettoria hanno preso questi Paesi, negli anni successivi? E come si colloca, in questa prospettiva, il percorso italiano, alla luce delle riforme e degli interventi giurisprudenziali in tema di licenziamento?
R.: In Germania e in Spagna non mi sembra che la disciplina dell’indennizzo per il licenziamento ingiustificato sia stata significativamente modificata nell’ultimo ventennio: sono rimasti invariati, in particolare, i rispettivi limiti massimi di 18 e di 24 mensilità dell’ultima retribuzione. In Francia, invece, nel 2015 si è assistito a una riforma legislativa che presenta una notevole analogia rispetto a quella italiana, cui ha fatto seguito un intervento del Conseil constitutionnel, la Corte costituzionale francese, di contenuto esattamente inverso rispetto a quello della nostra Consulta, n. 194/2018.
D.: Più precisamente, che cosa è accaduto in Francia?
R.: Nel 2015 il Governo francese ha promosso una modifica legislativa dell’apparato sanzionatorio in materia di licenziamenti – che peraltro era sempre stato anche in precedenza di natura esclusivamente indennitaria – secondo un modello molto simile a quello originario del nostro d.lgs. n. 23/2015, cioè nel senso di un collegamento stretto fra entità dell’indennizzo e anzianità di servizio del lavoratore: mi riferisco alla Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques n. 2015-715, a norma della quale l’indennizzo può variare da 1 a 20 mensilità dell’ultima retribuzione, con minimi e massimi differenziati in stretta relazione con l’anzianità di servizio. Nel promuovere l’emanazione di questa legge il Governo francese si è ispirato direttamente al nostro Jobs Act: posso affermarlo con certezza perché nel gennaio 2015 venni chiamato a Parigi da Stratégie France, agenzia di diretta emanazione dell’esecutivo d’oltralpe, per esporre, spiegare e discutere con alcuni funzionari ministeriali la riforma italiana. Sulla nuova legge francese è poi intervenuto il Conseil Constitutionnel con una sentenza del 5 agosto 2015, secondo la quale “mentre il criterio dell’anzianità di servizio nell’impresa è coerente con l’oggetto della legge, non altrettanto può dirsi del criterio dell’organico dell’impresa”. In Francia, dunque, è stato convalidato il meccanismo di stretta correlazione dell’indennizzo all’anzianità di servizio, mentre è stata abrogata la regola che imponeva al giudice di tenere conto anche delle dimensioni dell’impresa; in Italia tre anni dopo è accaduto esattamente l’inverso: in nome di un principio di “ragionevolezza” che evidentemente non teneva alcun conto della comparazione con la giurisprudenza d’oltralpe, la Corte costituzionale ha soppresso il nesso stretto fra indennizzo e anzianità di servizio e ha contestualmente indicato, tra i criteri che il giudice deve seguire nella determinazione dell’ammontare della condanna, anche le dimensioni dell’impresa (al di sopra della soglia dei 15 dipendenti).
 D.: L’apertura del diritto del lavoro al contributo della scienza economica – non ne fai mistero nel tuo saggio – non era stato accolto in maniera pacifica dalla dottrina giuslavoristica del tempo, preoccupata dalla possibile messa in discussione di schemi e concetti basilari della nostra cultura giudica. Ritieni ancora oggi valida questa constatazione, o a tuo avviso la riflessione scientifica si è aperta maggiormente, per volontà o per necessità, a questa contaminazione?
D.: L’apertura del diritto del lavoro al contributo della scienza economica – non ne fai mistero nel tuo saggio – non era stato accolto in maniera pacifica dalla dottrina giuslavoristica del tempo, preoccupata dalla possibile messa in discussione di schemi e concetti basilari della nostra cultura giudica. Ritieni ancora oggi valida questa constatazione, o a tuo avviso la riflessione scientifica si è aperta maggiormente, per volontà o per necessità, a questa contaminazione?
R.: Rispetto alla chiusura ermetica che si registrava ancora agli inizi del nuovo secolo osservo alcune aperture notevoli anche nella componente – chiamiamola così – più di sinistra dell’accademia giuslavoristica: nessuno oggi condivide un rifiuto a priori del confronto con la scienza economica. Osservo però – e non solo a sinistra, ma anche a destra – una tendenza diffusa a fare un uso molto selettivo e un po’ fazioso dei dati emergenti dalla ricerca economica e statistica, al solo fine di supportare le proprie scelte di politica del diritto. L’atteggiamento corretto, invece, consiste nel considerare con il dovuto interesse e apertura cognitiva tutti i risultati dell’analisi economica degli effetti delle norme: quello che chiamiamo il labour and economics approach. Su questo terreno in Italia siamo ancora molto indietro.
D.: Tra le questioni giuslavoristiche, il tema del licenziamento è senza dubbio quello maggiormente al centro della riflessone scientifica, ma anche del dibattito giurisprudenziale. Basta compiere, in questi termini, una semplice ricerca per parole in una qualsiasi banca dati di dottrina, per accorgersi di quanti contributi vi siano sulla materia. Vale la pena quindi oggi, per un giovane studioso, di concentrarsi su questo tema, cercando di portare qualcosa di “nuovo”? O c’è il rischio di limitarsi alla mera ricostruzione di un dibattito già ampio e nella maggior parte dei casi impostato in termini tradizionali?
R.: A me sembra che proprio il labour and economics approach dia accesso a spazi ancora poco o per nulla esplorati. Ne propongo soltanto un esempio: il problema della definizione del giustificato motivo oggettivo. Se esso non consiste nella ragionevole attesa di una perdita conseguente dalla prosecuzione del singolo rapporto di lavoro, qual è, precisamente, una definizione del g.m.o. che abbia un senso compiuto anche sul piano della micro-economia? E, se questa è l’opzione teorica, come si concilia il controllo giudiziale sul giustificato motivo – dal momento che la norma sarebbe svuotata di qualsiasi contenuto limitativo della facoltà di recesso, se la si potesse interpretare nel senso che il giudice deve solo accertare l’effettività della scelta dell’imprenditore – con l’insindacabilità delle scelte di gestione aziendale? Deve forse essere rivalutata l’idea – che sembrava essere stata definitivamente archiviata mezzo secolo fa – della funzionalizzazione (anche) dell’impresa privata all’utilità sociale? Se invece ci si colloca nella prospettiva della natura (anche) assicurativa del rapporto di lavoro e della definizione del suo contenuto in termini di “limite della perdita attesa conseguente alla prosecuzione del rapporto di lavoro che può essere imposta all’impresa”, come si concilia questa impostazione con l’onere della prova circa il g.m.o. a carico dell’imprenditore, dal momento che un evento futuro è suscettibile soltanto di valutazione probabilistica, non di prova, né documentale né testimoniale? Insomma, vedo ancora molto lavoro da fare su questo terreno per la nuova generazione dei giuslavoristi.
.


