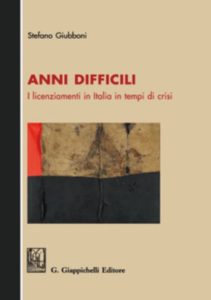Il confronto aperto sul terreno del Law & Economics implica la disponibilità a discutere di ciascun possibile contributo che dalla scienza economica viene non solo sul piano dello ius condendum, ma soprattutto su quello, peculiarmente proprio del giurista, dell’interpretazione delle singole norme e della ricostruzione sistematica
.
Le mie osservazione critiche sull’intervento di risposta di Stefano Giubboni (che riporto di seguito, per la maggiore comodità dei lettori) alla mia lettera-recensione del suo libro Anni difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi uscita, insieme alla risposta di S.G., sul n. 2/2021 della rivista Lavoro Diritti Europa .
.
 LE MIE OSSERVAZIONI CRITICHE SULLA REPLICA DI STEFANO GIUBBONI (che segue)
LE MIE OSSERVAZIONI CRITICHE SULLA REPLICA DI STEFANO GIUBBONI (che segue)
Ringrazio S.G. della sua risposta alla lettera aperta; il mio interlocutore però mi perdonerà se osservo che nel suo scritto trovo soltanto nella forma (che pure è già qualcosa di importante, beninteso), ma non nella sostanza l’inizio del dialogo puntuale che gli avevo proposto di aprire. Perché il dialogo vero implica il prendere sul serio gli argomenti proposti dall’interlocutore e replicare sul terreno specifico di ciascuno di essi. Cerco di spiegare meglio che cosa spero possa seguire a questa prima apertura formale, in riferimento a ciascuno dei cinque paragrafi in cui essa si articola, corrispondenti ai cinque paragrafi della mia lettera-recensione.
1. Su “i luoghi comuni da abbandonare e il confronto autentico con gli economisti”
S.G. sfonda una porta aperta quando scrive: “giudico sbagliato – sul piano metodologico – un approccio che pretenda di estrapolare lineari e univoche indicazioni di policy, valide in generale e a prescindere dal contesto al quale si applichino, da un certo specifico modello analitico”. Dimentica però che il dialogo tra diritto ed economia di cui parlo nella mia lettera aperta non riguarda soltanto, e neppure principalmente, le indicazioni di policy, bensì soprattutto l’opera peculiarmente propria del giuslavorista, cioè l’interpretazione della norma e la ricostruzione sistematica. A questo proposito, nella mia recensione ho fatto l’esempio della nozione di giustificato motivo di licenziamento, a proposito della quale sostengo che il giurista non può fare a meno di alcuni concetti mutuati dalla scienza economica (come quelli di “perdita attesa” e di “costo opportunità”): ecco un caso in cui il confronto non può ridursi alle frasi generiche e alle affermazioni generali di metodo. Ma a questo argomento anche ora S.G. non risponde.
Nella recensione gli contesto che questo argomento di rilievo centralissimo nella materia dei licenziamenti, oggetto di studio nelle opere di diversi giuslavoristi, è del tutto ignorato nel suo libro, pur interamente dedicato a questa medesima materia.
Allo stesso modo non trovo nella sua replica alcuna risposta riguardo all’argomento preciso che può trarsi dal modello insider/outsider per dubitare della costituzionalità di un ordinamento quale quello auspicato da S.G., che estendesse a tutti i rapporti di lavoro il regime di stabilità del lavoro proprio del settore pubblico. Che quell’argomento sia stato liquidato troppo frettolosamente nel libro è dimostrato dal modo in cui, sulla scia del libro stesso, esso viene liquidato in uno scritto di questi giorni a esso dedicato (Rita Sanlorenzo, in Questionegiustizia, 27 febbraio 2021), dove si denuncia “la cortina fumogena alzata intorno al ‘nucleo pesante’ di questo campo di lotta per il diritto, vestita di luoghi comuni (il conflitto tra insiders e outsiders)”: dove si vede come il rifiuto sommario dell’apertura al dialogo tra diritto ed economia del lavoro possa fare proseliti, trasformandosi in un rifiuto aprioristico, anche al di là delle intenzioni dell’Autore.
2. Su “la necessità di considerare superato un certo approccio di Law and Economics”
Prendo atto della drastica correzione del tiro: S.G. precisa che “superato” non deve considerarsi il Law and Economics nel suo complesso, come si legge nell’introduzione del suo libro, bensì soltanto l’Economic Analysis of Law (non entro qui nel merito dell’argomento usato per liquidare sommariamente come “superato” questo versante del L&E). Poi però pretende di appoggiare questo suo giudizio sul libro di Guido Calabresi del 2016; e qui vedo una forzatura davvero non accettabile. In quel saggio Guido Calabresi non considera affatto “superata” la branca dell’Economic Analysis of Law: egli chiarisce la distinzione tra questa, come terreno di competenza specifica degli economisti, e l’altra, cioè quella che contribuisce direttamente allo svolgimento del compito proprio del giurista, sia come interprete, sia come costruttore di norme; ma propone questa distinzione nell’ambito di un discorso che le valorizza convintamente entrambe.
Sta di fatto che anche in questo caso lo scritto già citato di Rita Sanlorenzo mostra quanto sia contagiosa la tentazione di squalificare in blocco l’approccio di Law and Economics, e quanto fuorviante possa essere proprio il modo in cui questo comparto delle scienze sociali è liquidato nel libro, anche al di là degli intendimenti del suo Autore: in quell’intervento della magistrata del lavoro, ancora una volta in perfetta aderenza a quanto si legge nel libro, si stigmatizzano i “richiami a dottrine tanto care a certa accademia pur dopo la loro dimostrata inefficacia (la tanto enfatizzata Law & Economics, già sconfessata all’estero ancor prima che da noi ne fiorissero gli aedi più accaniti)” (c.m.). All’autrice di queste righe, come a molti altri cultori della nostra materia, non par vero di poter liquidare la questione in questo modo, fidandosi di quanto legge nel saggio di un autorevole professore; ma proprio per questo i professori hanno il dovere di stare attenti a quello che scrivono.
Sarei comunque soddisfatto del fatto che S.G. “salvi” almeno uno dei due versanti del L&E, quello che costituisce oggi un capitolo universalmente riconosciuto come essenziale nella teoria generale del diritto, se ciò significasse che almeno questo viene preso davvero sul serio; invece, come mi propongo di mostrare nel paragrafo che segue, dalla parte immediatamente successiva della risposta di S.G. questo non risulta.
3. Sulla pretesa “scarsa rilevanza, per la nostra materia, della distinzione tra property e liability rules”
S.G. qui sostiene che “la tutela reintegratoria di cui all’articolo 18, sia nella vecchia che nella nuova formulazione, realizzi una tipica liability rule e non una property rule”; ma proprio il brano di Calabresi e Melamed che lui riporta a sostegno della sua affermazione dice proprio contrario.
L’articolo 18 St. lav., nella parte in cui prevede la reintegrazione del lavoratore come conseguenza del giudizio negativo circa il suo motivo o la sua forma, attribuisce al lavoratore stesso proprio quella facoltà di “veto if the buyer does not offer enough” che secondo la definizione di Calabresi e Malamed caratterizza la property rule. È infatti il lavoratore reintegrato che può decidere sovranamente se rinunciare al posto o no, stabilendone il prezzo senza limiti massimi. Sarebbe vero il contrario se, a seguito della reintegrazione, fosse il datore di lavoro a poter scegliere tra questa e l’indennizzo standard stabilito dalla legge; ma così non è: la scelta è data dall’articolo 18 al lavoratore. Qualificare questa norma come una liability rule, dunque, è possibile soltanto travisando gravemente il significato di questa distinzione concettuale fondamentale.
Non vedo, infine, la congruenza di questa istanza di (forzata) sussunzione dell’articolo 18 nel concetto di liability rule proposta da S.G. con la tesi dell’“intrinseca irrazionalità della tutela indennitaria”; e ancor meno con l’auspicio, esplicitato da S.G., dell’estensione a tutti i rapporti di lavoro del regime oggi proprio dell’impiego pubblico. A meno che S.G. sostenga la riconducibilità anche di quello al concetto di liability rule.
4. Sulla puntualizzazione circa la pretesa “intrinseca irrazionalità della tutela indennitaria”
Nella mia recensione in forma di lettera aperta ripropongo in estrema sintesi il ragionamento ampiamente esposto in numerosi scritti precedenti circa la nozione di giustificato motivo oggettivo come “perdita attesa dall’imprenditore dalla prosecuzione del singolo rapporto, superiore rispetto a una soglia considerata dall’ordinamento suscettibile di essere accollata all’impresa”; questo per sostenere una tesi diametralmente opposta rispetto a quella della “intrinseca irrazionalità della tutela indennitaria”: al contrario, proprio da quella nozione di g.m.o. deriva, a mio modo di vedere, l’intrinseca razionalità della sanzione indennitaria (che spiega anche perché tutti i Paesi del mondo abbiano adottato questa sanzione, se non addirittura la tecnica di filtro delle scelte imprenditoriali costituita dal severance cost predeterminato).
Ora, se la disponibilità di S.G. a confrontarsi sul terreno del L&E è reale, è su questa nozione di g.m.o. che deve prendere posizione, spiegando dove essa sia errata o comunque contrastante con la disciplina vigente. Invece anche nella sua replica non una parola è dato leggere a questo proposito.
5. Sul “neoliberismo degli anni perduti e la necessità di una riforma”
Nella recensione-lettera aperta chiedo a S.G.: se pecca di iper-liberismo la scelta compiuta con le riforme del 2012 e del 2015 di transitare da un regime fondato sulla job property a uno fondato su di una liability rule, di che cosa peccano gli altri ordinamenti europei, tutti centrati su di una liability rule e per di più su norme che prevedono livelli di indennizzo nettamente inferiori al nostro? La risposta di S.G. è, testuamente: “con il Jobs Act, il legislatore italiano ha compiuto una scelta di chiara impronta neoliberale, che peraltro la Corte costituzionale ha giudicato non compatibile con i principi costituzionali”. A me questa, francamente, non sembra una risposta a quella domanda. Anche perché la Corte costituzionale non ha considerato affatto incompatibile con i principi costituzionali né il passaggio dalla property rule alla liability rule, né l’entità massima dell’indennizzo risultante dalla riforma: la Corte si è limitata a indicare come incostituzionale il meccanismo di determinazione dell’indennizzo, entro il limite massimo indicato dal legislatore ordinario.
Poi, S.G. cita il monito di Kahn-Freund “sugli abusi della comparazione giuridica e sui rischi della ricorrente tentazione del legal transplant (perché l’Italia non è esattamente come la Germania, o la Francia, ma neppure come la Spagna, e men che meno come i Paesi delle virtù flessicuritarie, vere o presunte che siano)”. Ma S.G. dimentica – o sbaglio? – che Germania,  Francia e Spagna sono pur sempre Paesi soggetti a quello stesso diritto europeo, col quale la nostra nuova disciplina dei licenziamenti secondo lui sarebbe incompatibile, dunque a maggior ragione dovrebbe considerarsi incompatibile la loro. D’altra parte, se il rifiuto della “ricorrente tentazione del legal transplant” deve impedirci di confrontarci persino con i nostri partner europei, e la comparazione deve essere sempre paralizzata dalla “peculiarità del caso italiano”, il nostro europeismo a che cosa si riduce?
Francia e Spagna sono pur sempre Paesi soggetti a quello stesso diritto europeo, col quale la nostra nuova disciplina dei licenziamenti secondo lui sarebbe incompatibile, dunque a maggior ragione dovrebbe considerarsi incompatibile la loro. D’altra parte, se il rifiuto della “ricorrente tentazione del legal transplant” deve impedirci di confrontarci persino con i nostri partner europei, e la comparazione deve essere sempre paralizzata dalla “peculiarità del caso italiano”, il nostro europeismo a che cosa si riduce?
.
Per comodità dei lettori riporto qui di seguito
LA REPLICA DI STEFANO GIUBBONI ALLA MIA LETTERA APERTA
(cui si riferiscono le osservazioni critiche che precedono).
Sommario
1. I luoghi comuni da abbandonare e il confronto autentico con gli economisti
2. La necessità di considerare superato un certo approccio di Law and Economics
3. Sulla scarsa rilevanza, per la nostra materia, della distinzione tra property e liability rules (e sulla necessità di intenderla correttamente)
4. A scanso di equivoci, una doverosa puntualizzazione sulla mia opinione circa la tutela indennitaria
5. Il neoliberismo degli anni perduti e la necessità di una riforma
Caro Pietro,
ti sono grato per l’attenzione dedicata al mio libro Anni difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi (Giappichelli, 2020), e per gli importanti stimoli alla discussione che hai voluto rivolgere, a me e più in generale alla comunità dei giuslavoristi, con la tua lettera aperta. Anche io ritengo necessario mantenere viva la discussione all’interno della nostra comunità, che non mi pare, peraltro, si sia mai chiusa al confronto – che è al contrario sempre stato molto vivace, anche sullo stretto piano della politica del diritto – tra le sue diverse componenti. Non credo neppure che queste possano essere schematicamente divise in due campi così nettamente contrapposti, considerate le tante campiture e sfumature intermedie di colore.
Quello che semmai è mancato – in parte già in occasione dell’approvazione della legge Fornero (che fu per lo meno discussa in Parlamento, sia pure nelle peculiari contingenze a tutti note) e di certo ancor più con il Jobs Act, praticamente imposto con la tecnica del fait accompli sulla base di una delega che dava carta bianca al Governo – è un vero dibattito pubblico: un serio confronto politico e nella società civile (se posso usare un’espressione che può suonare ormai vagamente nostalgica). È questo il motivo per cui considero la sentenza che ha negato lo svolgimento del referendum promosso dalla CGIL una importante occasione mancata per il Paese. Non c’è dubbio, infatti, che ove la Corte costituzionale ne avesse dichiarato l’ammissibilità, il referendum avrebbe provocato un tale dibattito, sollecitando quantomeno Governo e Parlamento (come è in effetti avvenuto sugli altri temi referendari) a prendere una posizione, giustificandola (si spera) dinanzi all’opinione pubblica.
Prima di rispondere alle tue ficcanti osservazioni critiche vorrei fare – a beneficio di chi non ha letto il libro (e potrebbe del tutto legittimamente decidere di non leggerlo) – alcune puntualizzazioni sia di metodo che di merito. Che svolgerei molto brevemente nei seguenti termini: 1) ho voluto scrivere un libro “orientato”, come dichiaro nella introduzione, di critica radicale al legislatore delle controriforme del 2012 e del 2015 e, in parte, alla giurisprudenza fiorita su di esse; 2) l’esplicito e diretto obiettivo polemico (e di politica del diritto) del libro è dunque la vigente disciplina dei licenziamenti e solo secondariamente e di riflesso la dottrina che si è collocata su posizioni “simpatetiche” (e talvolta di sostegno organico) alle scelte del legislatore; 3) questo spiega perché, da un lato, non mi sono diffusamente confrontato con i tuoi lavori più di quanto non abbia fatto con quelli di altri autori che si collocano su posizioni analoghe alle tue (almeno quanto a opzioni ricostruttive ed esiti interpretativi) e, dall’altro, ho limitato le citazioni fondamentalmente al periodo successivo alle controriforme di questi “anni difficili” (di qui, quelle che tu consideri lacune nei riferimenti come nelle argomentazioni, e che certamente tali sarebbero state se il libro avesse avuto quegli intenti sistematici propri di una trattazione organica, che invece non ha per una precisa scelta, dichiarata in apicibus); 4) le poche battute polemiche che dedico nell’introduzione alla Law and Economics e allo schema analitico insider/outsider (come anche, ma del tutto en passant e in nota, alla distinzione tra property rules e liability rules) – ovvero ad alcuni dei costrutti teorici (non saprei dire se i più rilevanti) impiegati per fornire un impianto giustificativo di tipo economico alle scelte politiche dei Governi Monti e Renzi – sono del tutto secondarie (per non dire irrilevanti) ai fini del mio discorso critico de lege lata et ferenda, a tal punto che il libro manterrebbe una sua piena coerenza e – dal mio punto di vista – raggiungerebbe i suoi obiettivi, anche se decidessi di farne a meno (eliminando, semplicemente, l’introduzione); 5) ma è pur vero che l’introduzione ha una sua sicura utilità, perché dà al discorso quel tono polemico (quel poco di sapidità e di pepe, mi vien da dire), che mi pare sia servito a stimolare questa nostra discussione (e quindi la conserverò gelosamente ove mai dovessi pensare ad una nuova edizione).
Ciò premesso, posso passare a una risposta più precisa e puntuale ai tuoi importanti rilievi.
A questo proposito rimproveri essenzialmente alla mia impostazione di eludere in modo sin troppo sbrigativo il confronto con le teorie economiche e gli apporti dell’economia del lavoro, a partire da un più rigoroso approfondimento delle implicazioni di policy che derivano dal modello insider/outsider. Vorrei qui rispondere sciogliendo un equivoco metodologico sul quale avrò modo di tornare anche nel punto successivo.
Il confronto con i risultati della ricerca economica – come giustamente osservi – è certamente indispensabile, anche per il giuslavorista, soprattutto quando il suo discorso si colloca sul piano della politica del diritto (e ovviamente si orienti al rispetto e all’attuazione dei valori costituzionali). Ma proprio per questo giudico sbagliato – sul piano metodologico – un approccio che pretenda di estrapolare lineari e univoche indicazioni di policy, valide in generale e a prescindere dal contesto al quale si applichino, da un certo specifico modello analitico, di per sé parziale, e ancor più da una precisa dottrina o teoria economica.
Innanzi tutto, un approccio del genere accredita erroneamente alle teorie economiche – che sono straordinariamente articolate, diversificate e dialettiche (come ci ricorda ad esempio Alessandro Roncaglia nel suo più recente libro, significativamente intitolato L’età della disgregazione, Laterza, 2019) – quella sorta di monolitica e obiettiva univocità di esiti, che non è propria, a ben vedere, neppure delle scienze cosiddette dure. Affidarsi con atteggiamento dogmatico ad un certo modello teorico, con la pretesa di ingabbiare in regole conseguenti fenomeni complessi quali sono (anche) quelli della regolazione del mercato del lavoro, porta proprio al tipo di errore (e di vizio ideologico) che nel libro rimprovero al legislatore delle controriforme di questi anni: ovvero di non aver adeguatamente tenuto conto dei concreti risultati economici prodotti dalle misure introdotte (ad esempio in termini di aumento stabile dell’occupazione regolare a tempo indeterminato e di conseguente incentivo delle imprese ad investire sul “capitale umano”, per usare la citatissima espressione, uscendo da un modello competitivo alla lunga insostenibile, e che è difatti parte non trascurabile delle ragioni del declino italiano, qual è quello basato sulla svalutazione del lavoro e la compressione dei relativi costi, senza alcuna prospettiva di rilancio della produttività, stagnante da almeno un ventennio).
È su questo piano – rigorosamente applicativo e di verifica, misurazione e valutazione dei risultati effettivamente conseguiti, tra quelli voluti in sede di riforma – che dovrebbe invece necessariamente svolgersi il confronto con gli economisti, il cui apporto (insieme a quello di altri scienziati sociali, peraltro) è, quindi, certamente indispensabile. Ma è esattamente ciò che è mancato, per cui potrei ben rovesciare la tua critica e chiedere perché, ad esempio, si è proceduto – con la scelta del cosiddetto contratto a tutele crescenti – ad una ulteriore virata di segno cristallinamente neoliberale (o liberista, se preferisci) sulla disciplina dei licenziamenti (specie economici), senza una seria valutazione dei risultati prodotti dalla legge n. 92/2012. Nonostante l’enfasi posta da tale legge sui meccanismi di monitoraggio, evidentemente la verifica dei risultati non era il punto: onde potrei osservare, come ho fatto nel libro, che lo stesso uso di certe dottrine economiche è stato ideologicamente strumentalizzato a sostegno di obiettivi politici – come ovvio perfettamente legittimi e desiderabili – perseguiti a prescindere da un rigoroso confronto con i risultati della migliore ricerca economica applicata.
Chiarito questo passaggio, a mio avviso cruciale sul piano del metodo per impostare un corretto confronto con la scienza economica, deve essere anche chiaro che il giurista non può poi esimersi dal far valere ciò che gli è proprio: onde, a prescindere dai risultati cui conduca quel confronto, non può abdicare ad un rigoroso scrutinio delle scelte del legislatore alla stregua delle sue categorie. E di questo il mio libro si occupa: ed è fondamentalmente su questo piano – il solo, in definitiva, che propriamente ci compete – che è svolta quella critica radicale, sia alla legge Fornero che al renziano Jobs Act, per il quale esso è stato concepito.
- La necessità di considerare superato un certo approccio di Law and Economics.
Prima di venire al punto specifico relativo agli usi – e abusi – della Law and Economics vorrei completare il ragionamento accennato sopra.
Il confronto con la teoria economica (qualunque essa sia, beninteso), per esser tale, ovvero per potersi definire un dialogo utile e fecondo tra le due discipline, deve svolgersi a doppio senso di marcia, per così dire: deve, cioè, avvenire su basi di reciprocità. Ed è questo che intende Guido Calabresi, nel recente libro che citi anche tu, quando afferma, del tutto condivisibilmente, che la Law and Economics – nel senso, però, da lui precisato e sul quale tornerò tra breve – ha una indubbia e perdurante utilità, naturalmente insieme ad altri approcci metodologici (ad esempio, da vecchio “alunno” dell’Istituto Universitario Europeo, io resto affezionato – come credo dimostri il mio percorso scientifico – al metodo della law in context, che è a ben vedere null’altro che l’invito, che ci viene prima di tutto dai nostri grandi maestri del diritto del lavoro, a mantenere una costante apertura cognitiva, senza mai chiudersi nei recinti disciplinari).
Solo una tale apertura metodologica al dialogo interdisciplinare, anche con l’economia, consente infatti di evitare le secche e i pericoli di una recezione passiva e piuttosto supina dei costrutti che ci provengono dalla scienza economica, importandoli oltretutto – e paradossalmente – senza quel confronto dialettico (con le sue rigorose prove di falsificabilità) cui essi debbono invece rimanere assoggettati nella sfera di provenienza. Il rischio è, infatti, quello di tradurre in schemi rigidi – quali sono inevitabilmente le regole dell’ordinamento giuridico – i risultati, sempre parziali, imperfetti e mutevoli, di quelle teorie, ossificandoli in strutture dure che li isolano dal processo scientifico di trial and error. È a ben vedere quanto accaduto, sul piano “macro” (e costituzionale), con le regole della nuova governance economica e monetaria dell’Unione specie dopo la “stretta” del 2011-2013 (dal Six pack al Fiscal Compact al Two Pack), le quali hanno codificato – con gli effetti noti – uno specifico apparato di dottrine economiche (che pur avendo una ascendenza diversa, che va dal monetarismo nordamericano all’ordoliberismo tedesco, convergono, tuttavia, nella “presa” della precettistica operativa rigida e minuta che conosciamo). La disfunzionalità della costituzione macroeconomica dell’Unione – e dell’eurozona in particolare – origina da un tale vizio di fondo, e la difficoltà di porvi rimedio, ovviando almeno in parte ai guasti e alle insostenibili asimmetrie che essa ha prodotto (ad esempio tra Stati del centro nordeuropeo e periferia mediterranea), è esacerbata proprio dalla necessità di trovare, in sede politica e negoziale, il consenso che serve per una loro revisione (e da questo punto di vista la crisi pandemica costituisce davvero un’opportunità storica per l’Unione, visto che il Recovery plan contiene, in nuce, le possibilità di una sostanziale riforma di quelle regole).
Ho voluto fare questa breve digressione sulle regole della governance economica europea, non solo per la loro obiettiva importanza, anche per la nostra specifica discussione, ma perché ritengo che in quest’ambito si sia finalmente aperto, tra giuristi ed economisti, quel tipo di confronto e di dialogo che sarebbe auspicabile più in generale tra le nostre discipline. Esiste ormai una vasta letteratura nata da questo confronto, cui hanno preso parte alcuni tra i più autorevoli economisti e giuristi (basti pensare ai noti contributi di Stiglitz e a quelli di Joerges): qui vorrei limitarmi a segnalare l’esemplare ricerca curata da Luca Antonini (La domanda inevasa. Dialogo tra economisti e giuristi sulle dottrine economiche che condizionano il sistema giuridico europeo, il Mulino, 2016), perché credo che dovremmo fare interamente nostro l’invito “al recupero del rapporto tra diritto ed economia, nella prospettiva che, del resto, era stata già assunta da Adam Smith”, che Massimo Luciani ha formulato con la limpida enunciazione che riporto di seguito: “È compito del diritto far comprendere la relatività delle dottrine (in senso proprio, più che oggettive teorie) economiche, perché è il diritto che può mostrarne la connessione con concreti assetti di potere e non meno concrete strutture ordinamentali serventi” (Il costituzionalismo e l’economia dal divampare della crisi a oggi, ivi, spec. p. 64).
È proprio alla luce di questa giusta sollecitazione che posso ora chiarire meglio il fugace passaggio che faccio nell’introduzione del mio libro sulla “inattualità” e in ogni caso sull’esigenza di un superamento della Law and Economics – o meglio di un certo tipo di approccio della stessa –, nei termini indicati dallo stesso Calabresi. In effetti, in quel rapido passaggio, io non ho distinto, cosa che del resto non hai fatto neanche tu, tra la corrente di Law and Economics che ha in Guido Calabresi il prestigioso fondatore e la corrente che fa capo ad un altro grande giurista americano (anch’egli giudice e accademico), Richard Posner, e che dovremmo forse più propriamente chiamare – secondo la terminologia impiegata dallo stesso Calabresi – Economic Analysis of Law. È questa, in realtà, che io critico rifacendomi appunto a Calabresi e che ritengo sia oggettivamente in declino, come, a tacer d’altro, dimostra proprio l’autocritica del suo massimo esponente (v. in particolare R. Posner, A Failure of Capitalism, Harvard University Press, 2011). È lo stesso Calabresi a chiarire la profonda differenza di metodo e finalità tra i due approcci: “the difference between us was that Posner used economic theory to criticize and correct law, while Calabresi, though he did that too, more importantly also used law to suggest changes and alterations in economic theory” (così in The Future of Law and Economics, Yale University Press, 2016, p. 17).
La differenza fondamentale tra le due correnti di pensiero sta dunque esattamente in ciò, che soltanto la prima istituisce quella relazione bilaterale (ovvero di mutuo e scambievole condizionamento e arricchimento epistemologico) tra diritto ed economia, che è invece programmaticamente assente nella seconda, la quale usa una certa dottrina economica (essenzialmente il modello di massimizzazione dell’efficienza proprio della teoria neoclassica) per criticare il diritto vigente. L’orientamento unidirezionalmente ideologico di quella critica ne è la conseguenza inevitabile. Come sempre, del resto: quando si parte da un modello astratto e lo si applica schematicamente alla realtà, è giocoforza imbattersi in una sorta di circolarità tautologica tra premessa e conclusione del ragionamento; ed è per questo motivo che Guido Calabresi, nel suo celebre saggio con Douglas Malamed (Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View from the Cathedral, in Harvard Law Review, vol. 85, 1972, n. 6, pp. 1089-1128), invita a maneggiare con molta cura qualunque framework astratto di analisi del rapporto tra diritto ed economia (compreso il suo, naturalmente).
- Sulla scarsa rilevanza, per la nostra materia, della distinzione tra property e liability rules (e sulla necessità di intenderla correttamente).
La citazione fatta da ultimo mi offre il destro per rispondere subito (con un piccolo cambiamento dell’ordine delle tue osservazioni) ad un altro tuo rilievo critico (sul quale, peraltro, ho già preso posizione in premessa), ovvero quello relativo all’importanza che tu attribuisci – a mio sommesso avviso in modo eccessivo – alla famosa distinzione tra property rules e liability rules formulata in quell’articolo. Ho già detto che, ai fini del discorso che faccio nel mio libro, che è di critica al legislatore per come ha riscritto l’articolo 18 e per come ha disciplinato il licenziamento nel cosiddetto contratto a tutele crescenti, quella distinzione è praticamente irrilevante, ed è per questo che la richiamo solo incidentalmente in una nota del primo capitolo.
L’osservazione critica che mi rivolgi mi obbliga, nondimeno, a chiarire meglio il punto, spiegando in particolare perché (richiamando un saggio di Luca Nogler) anche io ritengo improprio, per quanto indubbiamente suggestivo, il tuo richiamo a quella distinzione. Anche qui mi pare doveroso partire da questa per come è esattamente formulata da Calabresi e Malamed, che così, a p. 1092 del loro saggio, la scolpiscono: “An entitlement is protected by a property rule to the extent that someone who wishes to remove the entitlement from its holder must buy it from him in a voluntary transaction in which the value of the entitlement is agreed upon by the seller. It is the form of entitlement which gives rise to the least amount of state intervention: once the original entitlement is decided upon, the state does not try to decide its value. It lets each of the parties say how much the entitlement is worth to him, and gives the seller a veto if the buyer does not offer enough. Property rules involve a collective decision as to who is to be given an initial entitlement but not as to the value of the entitlement”. Per contro, “Whenever someone may destroy the initial entitlement if he is willing to pay an objectively determined value for it, an entitlement is protected by a liability rule. This value may be what it is thought the original holder of the entitlement would have sold it for. But the holder’s compliant that he would have demanded more will not avail him once the objectively determined value is set. Obviously, liability rules involve an additional stage of state intervention: not only are entitlements protected, but their transfer or destruction is allowed on the basis of the value determined by some organ of the state rather than by the parties themselves”.
Ora, mi sembra difficilmente disputabile, rimanendo fedeli a questa definizione, che la tutela reintegratoria di cui all’articolo 18, sia nella vecchia che nella nuova formulazione, realizzi una tipica liability rule e non una property rule. Con la legge n. 92/2012 e poi con lo stesso d.lgs. n. 23/2015 non si è pertanto verificato un passaggio da una property rule ad una liability rule, ma si è semplicemente ridotto – e di molto (soprattutto nella originaria formulazione dell’art. 3 del decreto) – il valore, oggettivamente determinato dallo Stato, che chi licenzia (illegittimamente) è tenuto a pagare al titolare della situazione soggettiva di vantaggio (l’entitlement), nei casi in cui intenda farla venir meno (distruggerla, per tradurre alla lettera l’espressione di Calabresi e Malamed). Non è infatti mai esistito, neppure con il vecchio articolo 18, alcun potere di veto del titolare del diritto, che non è, né è mai stato, libero di determinare (a proprio totale arbitrio) il valore del bene protetto, che è invece oggettivamente fissato in base ad una decisione collettiva che richiede l’intervento di un qualche organo dello Stato (del giudice, nella specie). All’opposto di quanto avviene quando la situazione di vantaggio è viceversa protetta da una property rule, visto che (solo) in questo caso “no one can take the entitlement to private property from the holder unless the holder sells it willingly and at the price at which he subjectively values the property” (p. 1105).
Comunque, come ripeto, nell’economia del mio discorso critico sulla normativa italiana dei licenziamenti, reputo superfluo prendere posizione sulla questione, che per questo viene solo accennata.
- A scanso di equivoci, una doverosa puntualizzazione sulla mia opinione circa la tutela indennitaria.
Al riguardo mi attribuisci una posizione – alla cui stregua giudicherei sempre intrinsecamente irrazionale la tutela indennitaria riservata al licenziamento ingiustificato – che non ho espresso in nessun luogo, né nel libro, né nella conversazione su Giustizia insieme con Vicenzo Poso. Non sostengo, infatti, come dovrebbe risultare persino ovvio, visto che buona parte del libro è dedicato alle sentenze della Corte costituzionale, che una tutela meramente indennitaria sarebbe in quanto tale irrazionale e, dunque, contraria ai principi della Costituzione.
In effetti, nel libro, salvo qualche cenno, do per scontata l’ovvietà – da tempo acquisita, come ricordi – per cui il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nel congegnare i regimi di tutela, potendo benissimo scegliere una forma di rimedio soltanto indennitario, purché esso sia improntato a quei canoni di ragionevolezza, effettività e dissuasività che sono necessari per soddisfare lo standard costituzionale. Per non appesantire inutilmente il discorso, ho omesso di riprodurre nel volume il mio primo saggio sul d.lgs. n. 23/2015 (Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti, in Costituzionalismo.it, fasc. 1/2015), nel quale mi soffermavo più diffusamente su questo aspetto, per l’appunto assodato, pur rammentando anche la limpida posizione espressa dalle Sezioni unite della Suprema Corte nella sentenza n. 141/2006 riguardo al carattere privilegiato che dovrebbe riservarsi, in principio, alla tutela reintegratoria rispetto a quella di tipo indennitario.
Nel libro sostengo, invece, con qualche punta di veemenza polemica in alcuni passaggi, oltre ovviamente alla tesi della intrinseca irrazionalità della tutela indennitaria quale era stata oltraggiosamente congegnata dagli artt. 3, comma 1, e 4 del d.lgs. n. 23/2015 (ma questo ce lo ha detto ormai, e per fortuna, anche la Corte costituzionale, e se ne deve prendere atto), la tesi della irragionevolezza complessiva dell’attuale incongruo impianto dei regimi (prevalentemente indennitari) di tutela, quali oggi risultanti dal combinato disposto della legge Fornero e del Jobs Act, anche dopo le note e doverose correzioni. Per questo ho (non tanto provocatoriamente) sostenuto la tesi della necessità dell’abrogazione – oltre che del d.lgs. n. 23/2015, a mio avviso irredimibile (ma è evidente che esprimo qui un giudizio squisitamente politico) – anche delle norme della legge n. 92/2012, con un ritorno all’articolo 18 ante-controriforma.
Poi si può naturalmente discutere, come dico per la verità più nell’intervista a Poso che non nel libro, se possa essere opportuno, quantomeno per semplificare e parificare i regimi di tutela, che il modello di tutela reintegratoria – comune a lavoro pubblico e privato (per quest’ultimo ove applicabile, s’intende) – possa essere quello oggi disegnato dal nuovo art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. E si può anche discutere se, per i vizi formali-procedimentali (meno gravi), nell’area del lavoro privato (e forse persino in quella del pubblico impiego), possa essere opportuno avere una tutela meramente indennitaria (ancorché a mio avviso più robusta di quella oggi prevista). Probabilmente, sul versante della rimodulazione della tutela indennitaria, il problema a mio avviso più spinoso, almeno in prospettiva, è quello sollevato dalla palese inadeguatezza, di certo rispetto agli standard fissati dall’art. 24 della Carta sociale europea (rivista), della regola stabilita dall’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015. Ma se i miei voti dovessero mai essere esauditi – cosa ahimè improbabile, specie oggi direi –, quel problema non si porrebbe, visto che ci lasceremmo una volta per tutte alle spalle la fallimentare esperienza del d.lgs. n. 23/2015 (per ribadire ancora una volta la mia schietta preferenza politica).
Abbiamo del resto diverse opzioni di politica del diritto anche rispetto alla sentenza n. 25201/2016 della sezione lavoro della Cassazione sul giustificato motivo oggettivo, nella quale mi pare peraltro che la Suprema Corte, nell’accogliere l’interpretazione da me (e da tanti altri) criticata dell’art. 3 della legge n. 604/1966, segua un percorso esegetico-argomentativo suo, che non mi sembra del tutto sovrapponibile con quello che svolgi da tempo nei tuoi scritti.
- Il neoliberismo degli anni perduti e la necessità di una riforma.
A questa tua ultima considerazione critica vorrei replicare semplicemente che se anche fosse dimostrato che l’Italia conserva il regime protettivo più severo del pianeta (segnatamente con la tutela indennitaria di gran lunga più elevata rispetto a quelle previste in tutti i maggiori Paesi europei, come noti), non verrebbe meno l’esattezza dell’osservazione che, in particolare con il Jobs Act, il legislatore italiano ha compiuto una scelta di chiara impronta neoliberale, che peraltro la Corte costituzionale ha giudicato non compatibile con i principi costituzionali, neppure dopo l’innalzamento a 36 mensilità della misura massima della indennità risarcitoria. Si tratta infatti di un giudizio – di cui non nascondo l’implicita opzione o preferenza politica – che posso formulare, mi pare senza tema di smentita, assumendo come termine di raffronto il diritto italiano vigente ante-(contro)riforma.
Dopo di che è senza dubbio giusto e utile discutere di questo giudizio tranchant in un’ottica comparata, che non è, però, quella adottata dal libro, che non ha questa ambizione e questo respiro, limitandosi esso più modestamente a raccontare delle disavventure della disciplina italiana dei licenziamenti in questi interminabili difficili anni e della esigenza – sottolineata con forza dalla Corte costituzionale da ultimo nella sentenza n. 150/2020 – che il legislatore si faccia carico di riportare un ordine, arrivo a dire un ordine purchessia, al caos normativo che si è oggettivamente prodotto in Italia a causa delle improvvide riforme. Che il legislatore possa trarre ispirazione dalla esperienza di altri ordinamenti, possibilmente europei, è suggerimento sacrosanto di certo non nuovo, purché, però, si tenga sempre in debito conto il classico monito di Kahn-Freund sugli abusi della comparazione giuridica e sui rischi della ricorrente tentazione del legal transplant (perché l’Italia non è esattamente come la Germania, o la Francia, ma neppure come la Spagna, e men che meno come i Paesi delle virtù flessicuritarie, vere o presunte che siano).
Ma questo è tema per un altro libro, non per il mio.
.
.