Occorrono amministrazioni pubbliche più reattive e una rete di servizi al mercato del lavoro capace di attivare i percorsi mirati alle occasioni di lavoro esistenti (che si moltiplicano se sappiamo attivare quei percorsi)
.
Intervista a cura di Stefania Micheli, pubblicata sul quotidiano di Piacenza Il nuovo giornale il 20 novembre 2020, in occasione della mia conferenza presso la sede dell’Università Cattolica di quella città, nell’ambito della manifestazione Cives – Tutti gli altri articoli, interviste e commenti in materia di smart working pubblicati su questo sito sono agevolmente reperibili attraverso il portale dedicato a questo tema
.
.
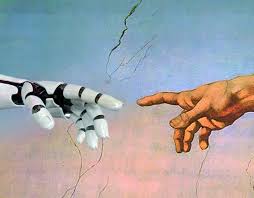 Professor Ichino, il tema dell’edizione Cives di quest’anno è “il Cambiamento”: ritiene che l’attuale emergenza sanitaria abbia portato qualche processo di cambiamento nel mondo del lavoro?
Professor Ichino, il tema dell’edizione Cives di quest’anno è “il Cambiamento”: ritiene che l’attuale emergenza sanitaria abbia portato qualche processo di cambiamento nel mondo del lavoro?
Lo shock del lockdown ha sicuramente prodotto, almeno nel settore privato, una forte accelerazione della diffusione delle tecnologie necessarie per lo smart working. Milioni di persone sono state costrette a familiarizzarsi con i nuovi strumenti, e con la possibilità stessa di organizzare incontri in forma telematica.
Lei dice “almeno nel settore privato”. Vuol dire che questo fenomeno non ha investito anche il settore pubblico?
Il lockdown ha certamente investito il settore pubblico, anche più di quanto abbia investito quello privato. Ma in quel settore un vero e proprio smart working lo si è visto soltanto in una piccola minoranza di casi, per lo più nelle amministrazioni locali: per il resto si è scelto di chiamare in questo modo quella che è stata in realtà una sospensione dell’attività di interi settori, da gran parte della Giustizia e dell’Agenzia delle Entrate al ministero del Lavoro, alla Motorizzazione Civile, alle Sovrintendenze, agli Ispettorati. Con questo non intendo sminuire quanto è stato fatto in piena pandemia dal Servizio Sanitario, dalle forze di Polizia, e da una parte degli insegnanti: quelli che hanno voluto e saputo tenere in piedi la scuola nonostante la pandemia.
Nelle altre amministrazioni pubbliche che cosa è mancato?
È mancata innanzitutto la capacità di distinguere chi nonostante tutto “tira la carretta” da chi si rassegna all’inerzia, o addirittura approfitta del lockdown per imboscarsi. La capacità di rilevare analiticamente ciò che accade settore per settore, ufficio per ufficio. Se lo si fosse fatto, ci si sarebbe accorti, tra l’altro, che nella maggior parte delle situazioni sono mancati tutti o la maggior parte dei presupposti essenziali per un passaggio serio dall’organizzazione tradizionale del lavoro allo smart working.
Quali sono questi presupposti?
Innanzitutto l’accessibilità da remoto del gestionale dell’amministrazione, oltre che dei suoi data-base. Poi, che la prestazione lavorativa si presti a essere misurata in base a compiti da eseguire anche da remoto, obiettivi da raggiungere, non essendo più misurabile in ragione della sola estensione temporale. Terzo: che la persona interessata sia dotata di un computer adatto, di un buon collegamento alla rete, e sia raggiungibile telefonicamente dai colleghi e dove necessario anche dall’utente. Infine, che essa sia dotata di un luogo adatto per lo svolgimento della prestazione: la maggior parte delle abitazioni non offre questa disponibilità.
Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo scriveva «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Il modo di agire delle amministrazioni che lei descrive ha forse effettivamente impedito una loro reale modernizzazione. Ritiene che oggi siano maturi tempi per un salto di qualità?
Il nostro è un Paese che sa anche dare il colpo di reni quando è necessario, ma tende ad aspettare l’ultimo momento utile: a darlo solo quando si trova sull’orlo del baratro. Il problema è convincerlo che sull’orlo del baratro ora ci siamo proprio. Che se vogliamo evitare di caderci dentro dobbiamo aprire gli occhi sui ritardi spaventosi delle nostre amministrazioni, sul piano culturale e organizzativo oltre che su quello tecnologico.
 Nel suo ultimo libro (Rizzoli, 2020) lei parla di “intelligenza del lavoro”, di un mondo dove i lavoratori possono scegliersi l’imprenditore, rovesciando il modo tradizionale d’intendere il mercato del lavoro. Ciò di cui parla nel libro è realtà o utopia?
Nel suo ultimo libro (Rizzoli, 2020) lei parla di “intelligenza del lavoro”, di un mondo dove i lavoratori possono scegliersi l’imprenditore, rovesciando il modo tradizionale d’intendere il mercato del lavoro. Ciò di cui parla nel libro è realtà o utopia?
È già oggi realtà per una metà abbondante della forza-lavoro: quella che è in grado di scegliersi l’impresa meglio in grado di valorizzare le sue capacità. Ma l’articolo 4 della Costituzione vincola la Repubblica a far sì che questa possibilità di scelta sia data a tutti i cittadini, non soltanto alla metà più dotata.
E questo secondo lei è concretamente possibile?
Certo che sì!
Come?
Per prima cosa ponendo tutte le persone interessate in grado di accedere ai grandi “giacimenti occupazionali” che restano inutilizzati, dei quali parlo nel primo capitolo del libro, e che ci sono anche oggi, nel cuore della crisi più grave che abbiamo mai attraversato. Per questo occorrono innanzitutto servizi capillari ed efficienti di orientamento scolastico e professionale, in particolare per gli adolescenti che escono da ciascun ciclo scolastico, ma anche per gli adulti disoccupati, o che intendono cambiare lavoro. Poi servizi di formazione mirati agli sbocchi effettivamente esistenti, la cui qualità sia controllata rigorosamente, con l’incrocio dei dati di una anagrafe della formazione con i dati delle Comunicazioni obbligatorie al ministero del Lavoro, delle iscrizioni agli albi ed elenchi professionali, e delle iscrizioni alle liste di disoccupazione. La capacità di formazione mirata, poi, ha un grande potere di attirare le imprese migliori.
.
