Appena due anni prima di Office in a Small City, nel 1951, un altro grande intellettuale statunitense, Frank Tannenbaum, aveva pubblicato il saggio A Philosophy of Labor, per sostenere che la grande impresa da sola non è in grado di darsi un’anima e che spetta al sindacato-intelligenza collettiva dei lavoratori aiutarla a trovarne una
.
Contributo pubblicato nel libro Edward Hopper – Puntare l’orizzonte, a cura di Giuseppe Frangi, GiGroup editore, dicembre 2020 .
.
Quell’estate del 1953, una notte Edward sogna di essere di nuovo a Nyack, la cittadina dove è nato, a poca distanza da New York. È all’ultimo piano di uno stabile del centro e da lì vede, molto vicino, l’ultimo piano dell’edificio dall’altra parte della strada: un palazzo signorile, vecchio ma non antico – a Nyack non esistono edifici che possano dirsi antichi – sul cui tetto spuntano diversi comignoli e il grande cilindro bianco di una cisterna. La mattina dopo racconta il sogno a Josephine, sua moglie. Le dice che solo in un secondo momento, nel sogno, si è accorto di essere in una specie di veranda costruita sopra uno stabile preesistente, da dov’era poteva vedere il fregio vecchio stile un po’ barocco che incorniciava la facciata di questo edificio, poco sotto di lui; ma lo spazio in cui lui si trovava era una struttura di cemento a vista, sicuramente di epoca molto più recente, squadrata e priva di qualsiasi ornamento, senza infissi a chiudere le due grandi luci che si aprivano su due lati.
Edward racconta alla moglie che, nel sogno, volgendo lo sguardo a sinistra vedeva a circa trenta metri di distanza una grande parete liscia fatta dello stesso cemento bianco, ma senza alcuna finestra, che faceva angolo rispetto alla strada chiudendo la vista verso nord. Dunque il locale dove si trovava era una propaggine di quello stesso edificio in cemento, che si era spinta fino al tetto del vecchio palazzo con il cornicione.
Nel sogno lui era seduto a un grande tavolo di legno grezzo, avrebbe potuto essere il tavolo di un falegname, ma senza attrezzi; ed era come se fosse vincolato alla sedia: avrebbe voluto alzarsi, ma non ci riusciva. Era una giornata fresca, tersa, senza una nuvola e neppure un filo di vento. Non un rumore. La luce era quella del sole a metà mattina, non ancora all’apice della sua corsa nel cielo. Era la stessa luce che Edward aveva dipinto quattro anni prima in High Noon, salvo che lì l’angolo della linea nettissima di confine tra luce e ombra disegnata dal sole di mezzogiorno sul muro era molto più vicino ai 90 gradi rispetto al suolo, mentre qui era attorno alla metà, 45 gradi. Lui avrebbe voluto vedere la città, il fiume, il mondo intero al di là dei comignoli del palazzo di fronte, ma non poteva. E – questa era la parte più angosciosa del sogno – aveva la sensazione che la parete di cemento bianca sulla sinistra, priva di qualsiasi apertura, stesse lentamente allungandosi, come fosse composta di pannelli scorrevoli che le consentivano di recingere il palazzo di fronte, divenendo così sempre più simile al muro di cinta di un carcere.
Josephine dice a Edward che deve provare a dipingere quello che ha sognato, anche se per rendere il movimento avvolgente della grande parete bianca un quadro non basta, sarebbe necessario un film. Lui raccoglie la sfida e si accinge subito all’opera, che lo impegnerà per diversi mesi; finché gli pare di essere riuscito a ricreare l’atmosfera del sogno e persino, forse, l’angoscioso allungarsi da sinistra della parete cieca di cemento.
La scena è invasa da una luce forte e immobile, che distingue molto nettamente le superfici in ombra da quelle investite dal sole, come nell’immagine fotografica statica risultante da una esposizione lunga della lastra. Le geometrie nette dello spazio in cui la figura del protagonista è iscritta richiamano le atmosfere metafisiche dei quadri di De Chirico, fatte per ispirare una sensazione di solitudine e inquietudine; un’atmosfera di attesa di qualche cosa di indefinito, che incombe su tutto come un destino ineluttabile.
A chi lavora in quel luogo è dato vedere il cielo al di sopra dell’edificio vicino, ma non il mondo che vive fuori, al di là dei comignoli; e non si tratta di un ostacolo alla vista paragonabile alla siepe leopardiana, che evoca un infinito pieno di suggestioni, bensì di un impedimento alla vista ostile e muto, in tutto analogo al cornicione che la impedisce in House by the railroad: un quadro dipinto dallo stesso Hopper nel 1925, quasi trent’anni prima. Cosicché il protagonista è come incastrato nel suo punto di osservazione, privato dell’orizzonte e dunque, letteralmente, della possibilità di orizzontarsi, di dare un senso alla propria esistenza. Oggetto di un “divenire senza centro” (l’espressione, riferita in generale alle persone dipinte da Hopper, è di Paolo Balmas).
Il protagonista non è in piedi, ma seduto; non è lì come osservatore indipendente: quello è il suo posto di lavoro; e, che lavori o si perda in propri pensieri, lì deve stare ancora per la maggior parte della giornata. Josephine, assistendo alla nascita del quadro giorno dopo giorno, non tarda a coglierne il significato profondo; e propone come titolo The man in concrete wall, che potremmo tradurre “l’uomo nel muro di cemento”, o forse, più liberamente, “l’uomo e la parete di cemento”.
Edward, ora che è riuscito a dominare il suo sogno dandogli vita sulla tela, preferisce un titolo più neutro: Office in a Small City. Il minimalismo di questo titolo, però, non deve ingannare: l’“ufficio” non è un posto di lavoro qualsiasi, bensì la condizione esistenziale dell’uomo nella grande azienda, la quale non solo opera come una monade impenetrabile rispetto al mondo circostante, ma al tempo stesso è capace addirittura di occluderlo.
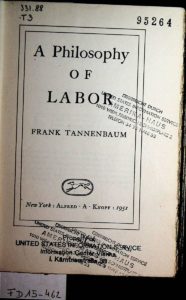 La struttura aziendale soffoca la small city che la ospita; essa stessa appare senza vita, senz’anima, fine a sé stessa e incapace di dare un significato e un futuro al lavoro che in essa si svolge. Il protagonista è ingabbiato in questa struttura, bloccato; il cielo terso di fronte a lui non è fonte di speranza, ma solo di un senso profondo di paralisi. Vien fatto di ricordare che appena due anni prima, nel 1951, un altro grande intellettuale statunitense, Frank Tannenbaum, aveva pubblicato il saggio A Philosophy of Labor, per sostenere che la grande impresa da sola non è in grado di darsi un’anima e che spetta al sindacato-intelligenza collettiva dei lavoratori aiutarla a trovarne una. Per evitare che il sogno angoscioso di Edward Hopper diventi una realtà da incubo.
La struttura aziendale soffoca la small city che la ospita; essa stessa appare senza vita, senz’anima, fine a sé stessa e incapace di dare un significato e un futuro al lavoro che in essa si svolge. Il protagonista è ingabbiato in questa struttura, bloccato; il cielo terso di fronte a lui non è fonte di speranza, ma solo di un senso profondo di paralisi. Vien fatto di ricordare che appena due anni prima, nel 1951, un altro grande intellettuale statunitense, Frank Tannenbaum, aveva pubblicato il saggio A Philosophy of Labor, per sostenere che la grande impresa da sola non è in grado di darsi un’anima e che spetta al sindacato-intelligenza collettiva dei lavoratori aiutarla a trovarne una. Per evitare che il sogno angoscioso di Edward Hopper diventi una realtà da incubo.
.

