L’obiettivo di assimilare la scienza economica alle scienze naturali è irraggiungibile e sbagliato – Ciò non toglie che l’economia, come le altre scienze sociali, sia un’impresa conoscitiva di straordinario fascino e interesse, proprio perché necessita di qualità diverse da parte degli studiosi
.
Lezione tenuta da Michele Salvati il 12 ottobre 2015 per il Centro Linceo interdisciplinare “Beniamino Segre” presso il Collegio Universitario Luigi Lucchini di Brescia – In argomento v. anche la lettera dello stesso Salvati 15 giugno 2017 sulla questione dei rapporti tra giuristi ed economisti, nonché gli interventi nel dibattito sullo stesso tema, di cui ivi si trovano i link
.
.
 Premessa e avvertenze
Premessa e avvertenze
L’economia e le altre scienze sociali –uso anche l’espressione scienze umane come sinonimo- non sono scienze dello stesso tipo delle scienze della natura. Con questa affermazione generica –ma la preciso in seguito- gran parte degli scienziati sociali sarebbero d’accordo e in essa non vi è nulla di denigratorio: si tratta di imprese conoscitive altrettanto difficili, esigenti e affascinanti. E comunque si tratta –insieme alla storia- degli unici strumenti di cui si dispone per cercare di capire le società in cui viviamo o abbiamo vissuto, o di cercare di prevedere, nei casi più ambiziosi, i tratti principali di quelle in cui vivremo. E di conseguenza intervenire su di esse in modo razionale, disegnando strumenti (politiche, istituzioni) atti a migliorare le condizioni di vita di coloro che di quelle società fanno parte. Dunque “ingegnerie sociali”, come dalle scienze “vere” abbiamo derivato le ingegnerie che ci hanno consentito il dominio sulla natura di cui oggi disponiamo e il benessere di cui godiamo.
Ma è proprio riflettendo sulle ingegnerie, sulle applicazioni, che la differenza tra i due tipi di “scienze” appare con maggiore evidenza. Dalle scienze della natura deriviamo conoscenze certe e precise, con le quali intervenire nel contesto naturale in cui viviamo e ottenere effetti prevedibili. Conoscenze sulle quali gli scienziati concordano, passando poi il compito di disegnare gli strumenti di intervento agli ingegneri e ai tecnici. Queste conoscenze certe e precise, sulle quali tutti gli scienziati concordano, mancano nelle scienze umane, o sono insufficienti, e restano in vita in modo permanente spiegazioni diverse su come l’economia e le società funzionino. In presenza di spiegazioni diverse, nessuna delle quali dispone di un consenso unanime nella comunità scientifica, non si può avere una “ingegneria” condivisa: in particolare, per l’economia, una politica economica sulla quale tutti gli economisti sono d’accordo. Il disaccordo nasce talora da un conflitto politico o valoriale, sulle finalità che si dovrebbero perseguire. Ma anche se c’è accordo politico, sui fini, può esserci disaccordo sui mezzi per raggiungerli, che deriva dalle diverse teorie con le quali gli scienziati sociali cercano di spiegare il funzionamento dell’economia e della società: vedremo tra poco, ad esempio, che ci può essere accordo politico sulla desiderabilità della piena occupazione, ma disaccordo scientifico su come raggiungerla.
Va ovviamente ricordato che ci sono stati e ci sono tuttora conflitti anche tra gli scienziati della natura –la scienza è lotta tra idee e ipotesi diverse- ma essi avvengono sulla frontiera dell’innovazione scientifica e sono destinati a ricomporsi: la teoria vincitrice ingloba poi quella sconfitta in un continuo processo cumulativo e così si manifesta il progresso scientifico. Ai fini delle applicazioni ingegneristiche questo fa sì che gran parte di esse rimangano utilizzabili anche quando la frontiera della conoscenza è in subbuglio. Ciò non avviene nelle scienze sociali, dove differenze radicali permangono e impediscono cumulatività e progresso.
- Perché le scienze sociali differiscono da quelle della natura
Da dove deriva, da ultimo, il disaccordo endemico nelle scienze sociali, la compresenza ineliminabile di diverse teorie su come funziona la società e l’economia? Dal fatto che, per “spiegare” in modo comprensibile e soddisfacente per coloro ai quali la spiegazione è rivolta, esse si devono riferire al comportamento umano, alle motivazioni che lo inducono, alle conoscenze –incerte, interdipendenti, mutevoli, parziali- sulle quali le motivazioni, e di conseguenza i comportamenti, si basano. Così ha da sempre “spiegato” la storia e così devono spiegare quelle discipline che pretendono di estrarre dalla storia uniformità (se non proprio “leggi”) che si applicano in via generale a molti casi storici, se non a tutti.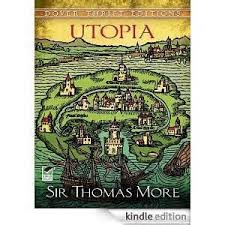 Di questa modalità di spiegazione vi do un esempio molto precoce e divertente, che precede di molto la nascita delle scienze umane moderne e troviamo in un libro famoso (Utopia, di Tommaso Moro, 1527). In esso viene descritto un colloquio tra il Primo Cancelliere del Regno e un grande viaggiatore, un grande esperto, di nome Raffaello: perché in Inghilterra, rispetto ad altri paesi confrontabili, gli assassinii sono così numerosi? Perché il furto è punito con la pena capitale – risponde Raffaello – mentre altrove è punito con pene più miti. E la risposta è argomentata con un ragionamento che è un tipico modello di spiegazione delle scienze sociali. Le persone del tutto prive di mezzi hanno tre alternative: non rubare e morire di fame; rubare senza uccidere, con probabilità elevata di essere riconosciute, arrestate e messe a morte; rubare, ammazzando chi potrebbe riconoscerle. La terza alternativa sarà quella adottata in modo prevalente.
Di questa modalità di spiegazione vi do un esempio molto precoce e divertente, che precede di molto la nascita delle scienze umane moderne e troviamo in un libro famoso (Utopia, di Tommaso Moro, 1527). In esso viene descritto un colloquio tra il Primo Cancelliere del Regno e un grande viaggiatore, un grande esperto, di nome Raffaello: perché in Inghilterra, rispetto ad altri paesi confrontabili, gli assassinii sono così numerosi? Perché il furto è punito con la pena capitale – risponde Raffaello – mentre altrove è punito con pene più miti. E la risposta è argomentata con un ragionamento che è un tipico modello di spiegazione delle scienze sociali. Le persone del tutto prive di mezzi hanno tre alternative: non rubare e morire di fame; rubare senza uccidere, con probabilità elevata di essere riconosciute, arrestate e messe a morte; rubare, ammazzando chi potrebbe riconoscerle. La terza alternativa sarà quella adottata in modo prevalente.
Questo è un tipico modello di spiegazione nelle scienze umane ed in particolare in economia (individualismo metodologico). Un “fatto sociale” (la maggior frequenza di assassinii) è spiegato facendo riferimento alle azioni individuali che ad esso conducono. A loro volta queste sono spiegate dai motivi e dalle conoscenze che inducono i singoli a compierle, motivi e conoscenze comprensibili e soddisfacenti per chi cerca una spiegazione di quel fatto problematico. Si noti che questa spiegazione può essere espressa nella forma di una piccola legge causale: se A (punizione eccessiva del furto), allora B (grande numero di assassinii), una legge all’apparenza non dissimile da quelle enunciate dalle scienze naturali. Ma, a parte il fatto che essa non consente di dare indicazioni numeriche precise, questa legge è basata su credenze e motivazioni umane. Credenze necessariamente parziali e diverse, mutevoli da luogo al luogo e da epoca a epoca. Nel caso di Raffaello la spiegazione è grosso modo soddisfacente perché si tratta di un fatto sociale semplice e circoscritto. Ma se si estende questo tipo di spiegazione all’intera economia e società, le cose si complicano: le motivazioni dei soggetti possono essere diverse, le loro informazioni incomplete, l’elaborazione di queste allo scopo di prendere una decisione può essere difficile e imperfettamente razionale, l’interazione tra i comportamenti dei singoli può dar luogo a esiti d’insieme difficilmente anticipabili.
Insomma, ed è il problema di fallibilità, la visione del mondo esterno sulla base del quale gli attori umani prendono decisioni, è sempre parziale e distorta. Distorsione e parzialità possono indurre a decisioni sbagliate, che non consentono di raggiungere i risultati che gli attori desideravano. A loro volta le reazioni a questi esiti indesiderati possono condurre ad esiti ancor più lontani dagli obiettivi degli agenti, producendo effetti cumulativi perversi e vedremo in seguito il caso del ciclo economico: se la domanda che si rivolge alle imprese è inferiore di quella attesa, la reazione di difesa delle imprese può essere quella di ridurre investimenti e occupazione. Ma questo può indurre una domanda e profitti ancor minori, e via di seguito. Questo è il problema della riflessività: in una storia che si sviluppa nel tempo, le aspettative e le concezioni degli attori influenzano il corso degli eventi; ma a sua volta il corso degli eventi influenza le aspettative e le concezioni degli attori, in un loop di interazioni dalle quali è difficile estrarre regole generali. E c’è infine un’ulteriore problema che rende difficile costruire una scienza sociale con le stesse ambizioni esplicative e ingegneristiche di una scienza della natura: il problema della parzialità. Per costruire un modello di spiegazione, una scienza sociale deve ritagliare dal flusso degli eventi storici un insieme di fenomeni che intende spiegare. E faccio un altro esempio. Lo sviluppo economico – il tasso di crescita del reddito reale procapite e perché in un paese è maggiore/minore che in un altro- non dovrebbe essere un problema centrale per gli economisti? Di fatto così è stato per una fase non breve della nostra disciplina, e ci ritorneremo. Per il grosso degli economisti teorici oggi non è più così, ciò che costringe coloro che del problema si vogliono occupare a ricorrere a modelli in cui hanno un peso dominante variabili e argomenti di cui i loro colleghi non si occupano e sono invece l’oggetto di altre scienze sociali, il diritto, la sociologia, le scienze politiche, quando non ricorrono direttamente ad argomentazioni storiche. Ma questi modelli importati sono ancor più soggetti, se trattati col metodo della spiegazione attraverso l’individualismo metodologico, alla fallibilità e riflessività di cui abbiamo appena scritto e ancor meno riconducibili ad ambizioni “scientifiche”.
Concludo su questo punto. La spiegazione nelle scienze umane, minata da fallibilità, riflessività e parzialità (e staticità, come vedremo in seguito per la teoria oggi prevalente), non si oppone di per sé alla formulazione di leggi causali. Si oppone alla definizione di leggi precise e stabili nel tempo e nello spazio, leggi che funzionano universalmente, che tutti gli scienziati sociali accettano come valide e sulla base delle quali consigliano “ingegnerie sociali” efficaci. Com’è evidente anche dalle polemiche che raggiungono i media e il pubblico dei non esperti, le ingegnerie consigliate possono essere molto diverse –si pensi a quelle dedicate al miglioramento delle condizioni economiche dei paesi più deboli dell’Unione Europea- e questa diversità, lo ripeto, non dipende solo da obiettivi politici diversi, perché tutti sostengono che le loro ricette accrescerebbero il reddito e l’impiego in Grecia, Italia, Spagna o Portogallo. La diversità delle ingegnerie trova origine nella diversità dei modelli scientifici adottati. Molto diversa è la situazione nelle scienze della natura, in un tipo di spiegazione scientifica non basata su conoscenze, motivazioni e comportamenti umani, ma su uniformità permanenti del mondo fisico, e dunque su ipotesi controllabili ed esperimenti replicabili: non c’è Fallibilità, o Riflessibilità o Parzialità che possa inquinare le leggi delle scienze della natura e l’ingegneria basata su di esse è solida ed efficace.
- Origini della scienza economica
Finora mi sono limitato a considerazioni di metodologia delle scienze sociali o di filosofia della conoscenza, indispensabili ma difficili da seguire per chi non ha pratica di quelle scienze. Dopo un breve cenno al momento storico in cui emergono le principali scienze umane, cercherò di dare un’idea, limitandomi all’economia, della teoria oggi dominante (neoclassica) e di quella prevalente dalle origini della disciplina sino alla fine dell’ottocento (classica). Poi darò due esempi, molto importanti, nei quali la teoria dominante non ci assiste, e proprio per le ragioni di fallibilità, riflessività, parzialità che ho prima menzionato. E per una ragione in più, la staticità, di cui dirò in seguito parlando della teoria neoclassica.

Galileo e Copernico
Le scienze umane si staccano dalle riflessioni dei filosofi, dei giuristi, dei teologi, degli storici – nel caso dell’economia anche dalle riflessioni pratiche sulla gestione del patrimonio della famiglia o del principe – a partire dalla grande svolta dell’età moderna, verso la fine del 17° e l’inizio del 18° secolo, circa un secolo dopo che si erano rese autonome le scienze della natura. In quel contesto razionalistico –non essendo più credibili le “spiegazioni” teologiche- si impone una domanda: perché non affrontare lo studio della società nello stesso modo in cui Galileo o Copernico, Keplero o Newton, avevano affrontato lo studio della natura? Non era forse possibile trovare anche per la società e l’economia delle spiegazioni analoghe alle loro? Non posso entrare in questa storia affascinante e, per l’economia, posso solo raccomandarvi un buon libro che la racconta, La ricchezza delle idee, di Alessandro Roncaglia (Laterza). Mi è solo possibile dare una prima idea dei suoi principali passaggi, la formazione dei suoi paradigmi prevalenti: quello “classico”, tra la metà del 700 e la fine dell’800, e quello “neoclassico”, da allora sino ad oggi. E poi fornire una prima idea dei problemi ai quali il paradigma tuttora dominante non riesce a dare una risposta adeguata, che raccolga il consenso della comunità scientifica, e questo proprio in conseguenza dei caratteri che distinguono le scienze umane da quelle della natura.
- L’economia classica
La teoria economica moderna, e il suo primo paradigma, nascono proprio dalla riflessione sul problema della crescita, dalla constatazione che l’economia stazionaria dei secoli precedenti aveva imboccato un sentiero di sviluppo che si staccava nettamente dal ristagno precedente: il reddito, la struttura dell’occupazione, le tecniche non erano molto cambiati dal medioevo al XVIII° secolo, salvo periodiche oscillazioni dovute in buona misura a guerre, pestilenze o fenomeni naturali. Da allora prende però inizio un periodo di crescita e trasformazione continuo, una accelerazione che nel corso di tre secoli condurrà una parte ampia della popolazione mondiale alla ricchezza dei nostri giorni: un processo documentato da molti storici economici e, da ultimo, da Angus Deaton in un bel libro, di facile lettura, da poco tradotto in italiano (La grande fuga, Mulino).

Adam Smith
Questo avveniva a seguito di una doppia rivoluzione, una rivoluzione sociale (il capitalismo) e una rivoluzione industriale: una sempre maggiore divisione e specializzazione del lavoro, il distacco di un sempre maggior numero di lavoratori dall’agricoltura e dall’artigianato diffuso e la loro concentrazione in grandi opifici, un continuo miglioramento dei trasporti, l’uso di fonti energetiche sempre più potenti e di macchine sempre più efficaci. Da metà del 700 questi fenomeni erano sempre più evidenti nel paese allora più avanzato, la Gran Bretagna, e non meraviglia che i primi grandi economisti moderni fossero inglesi o vivessero in Gran Bretagna. Adam Smith (Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, 1776) pone questi processi – capitalismo e rivoluzione industriale – al centro delle riflessioni della nascente scienza economica e tali rimarranno per un secolo, fino all’avvento, verso la fine dell’ottocento, di un altro centro di interesse, quello dell’ottima allocazione delle risorse, guidata dalle preferenze di consumatori nell’abito di mercati perfettamente concorrenziali. I giganti del primo grande paradigma dell’economia sono, oltre a Smith, Ricardo e Marx: più tecnico Ricardo, che il capitalismo dà ormai per scontato, più ampi nel loro approccio Smith e Marx, studiosi anche delle origini storiche e degli aspetti sociali di questa straordinaria trasformazione della società. In tutti loro l’obiettivo di fondo era però quello di scoprire le forze che determinavano l’ampiezza delle risorse investibili, del sovrappiù, oltre i consumi necessari dei lavoratori e quelli improduttivi dei ceti non coinvolti nell’ampliamento della produzione, sostanzialmente i ceti aristocratici: minori i consumi di lusso di costoro, minori i salari e maggiore la produttività del lavoro, maggiore sarebbe stato il sovrappiù investibile in nuove attività produttive e dunque maggiore la crescita del paese. Si trattava quindi di scoprire i fattori che determinavano il prezzo delle merci, ed in particolare di quelle consumate dai lavoratori, che a loro volta determinavano il salario necessario alla loro sopravvivenza, nonché di stimare l’onere dei consumi improduttivi: di conseguenza il sovrappiù investibile sarebbe risultato per sottrazione dal prodotto complessivo dell’economia.
Questa visione del compito principale della scienza economica ebbe grande successo e ne vennero derivate conseguenze pratiche importanti di politica economica, di “ingegneria”. Fu famoso il dibattito politico sulle leggi sul grano, nella prima parte dell’800, in cui Ricardo argomentò con successo che non conveniva all’Inghilterra mettere dazi elevati sulle importazioni di grano, che ne avrebbero alzato il prezzo e costretto ad aumentare i salari, essendo il grano il principale alimento dei lavoratori ed essendo i salari fissati a un livello di sussistenza. Sarebbero aumentate le entrate dei produttori nazionali di grano, dei latifondisti agrari, in prevalenza aristocratici improduttivi, ma sarebbe diminuito il sovrappiù destinato all’accumulazione e alla crescita del paese. Gli aristocratici furono sconfitti, gli imprenditori industriali ebbero la meglio, il sovrappiù restò elevato e lo sviluppo industriale poté procedere ininterrotto.
- L’economia neoclassica
Verso la fine dell’800, capire la logica dello sviluppo capitalistico non era più avvertito come problema ed erano emerse inoltre alcune aporie logiche nella teoria classica, in particolare circa il problema della determinazione dei prezzi delle merci che quella teoria spiegava sulla base dell’ammontare delle quantità di lavoro necessario a produrle. L’attenuarsi di un grande interrogativo, la presenza di difficoltà teoriche irrisolte, l’affacciarsi di altri problemi meritevoli di interesse furono all’origine dell’affermazione di un nuovo paradigma, di una nuova visione dei compiti della scienza economica, quello che tuttora prevale, la teoria neoclassica o marginalistica.
A differenza della visione classica, che partiva da un problema storico ben definito (il capitalismo e la rivoluzione industriale), non esitava a utilizzare generalizzazioni sociologiche circa il comportamento di agenti collettivi (classi sociali: borghesia imprenditoriale, lavoratori salariati, aristocratici improduttivi..), il nuovo paradigma rispetta rigorosamente i canoni dell’individualismo metodologico: i suoi soggetti sono i singoli individui e il proposito dell’indagine è quello di studiare come si determinino prezzi e quantità di un numero indefinito di beni in condizioni di mercati competitivi, con tecniche di produzione date. Vengono a tale scopo imputate ai singoli agenti funzioni di preferenza con riferimento ad ogni singolo bene: dunque come scegliere tra beni diversamente desiderabili e costosi, nonché conoscenze e capacità computazionali sufficienti a scegliere in modo razionale, massimizzando la proprio utilità complessiva. Questo per gli agenti in quanto consumatori. In quanto produttori, vengono assunte come note agli agenti tutte le tecniche produttive disponibili per i diversi beni, e i mercati stabiliranno i prezzi per i fattori di produzione che esse richiedono: l’ipotesi di comportamento è la massimizzazione del profitto. Note le funzioni di preferenza e di produzione, assunte conoscenze complete da parte degli agenti, la massimizzazione dell’utilità e del profitto nel contesto di mercati competitivi consente di determinare prezzi e quantità dei fattori di produzione e di tutti i beni scambiati e prodotti. Poiché tra i fattori ci sono i vari tipi di lavoro, di capitali e di beni primari, risulta determinata anche la distribuzione del reddito tra i proprietari di questi fattori, dunque tra salari, profitti e rendite. E nel contesto di mercati competitivi, con prezzi dei beni e dei fattori sensibili agli impulsi della domanda e dell’offerta, risultano esclusi esiti non voluti dagli agenti. Ad esempio la disoccupazione involontaria: se le statistiche registrano un gran numero di persone che non hanno un’occupazione remunerata, ciò significa solo che ai salari di mercato essi non hanno intenzione di lavorare.

Gary Becker
È difficile, per chi non l’ha studiato, capire il fascino di questo paradigma. Esso descrive e formalizza in modo mirabile un mondo inventato, un mondo stazionario di permanente equilibrio, un mondo di agenti onniscienti, da cui sono esclusi i fenomeni più significativi di un’economia reale: l’innovazione, l’incertezza, le crisi, la crescita. Gli economisti neoclassici ritengono che l’eliminazione di questi fenomeni dal modello di equilibrio siano un prezzo che vale la pena di pagare al suo rigore formale: anche se consapevoli che staticità, parzialità, fallibilità e riflessività non consentono di derivare dal modello una descrizione realistica di come l’economia effettivamente funziona, essi sono convinti che la forma mentis che il modello induce in chi lo adotta sia importante per affrontare con successo gran parte dei problemi che un economista e uno scienziato sociale in genere devono risolvere. Gary Backer, un famoso economista, esprime in modo estremo questa convinzione: “le assunzioni di comportamento massimizzante, di preferenze stabili e di equilibrio di mercato, applicate senza sosta ed esitazione, formano il cuore dell’approccio economico”. In modo meno estremo altri arrivano a conclusioni simili, invocando la necessaria differenza tra descrizione realistica e modello teorico. Ma non di questo si tratta: quella differenza certamente esiste ed è inevitabile anche nelle scienze naturali. Il problema è se il modello teorico e la forma mentis da esso indotta consentono una comprensione adeguata dei fenomeni che gli economisti intendono spiegare. O se invece conducono a piste di ricerca sbagliate o irrilevanti. La discussione non può essere ora proseguita in termini generali, e cerco allora di giustificare la mia convinzione che è vera la seconda alternativa –che il modello neoclassico può condurre a conclusioni sbagliate o irrilevanti- mediante i due esempi già menzionati, che riguardano problemi tra i più importanti dell’economia: le crisi economiche e lo sviluppo.
- Le crisi economiche
Le crisi sono un fenomeno endemico e ineliminabile in un’economia di mercato, dove le decisioni che determinano l’ammontare del reddito e dell’occupazione sono prese da milioni di decisori indipendenti, sulla base di obiettivi di consumo e investimento tra loro non coordinati: in questa situazione, misteriose non sono le crisi ma l’assenza di crisi. Misterioso è il funzionamento soddisfacente di un’economia di mercato. Il modello di equilibrio statico che ho prima sommariamente. ricordato non contempla l’insorgenza di crisi, di un crollo imprevisto del reddito, di disoccupazione involontaria: in condizioni di concorrenza perfetta, in un mondo di decisori razionali e onniscienti, esiste sempre un equilibrio di mercato, anche per il mercato del lavoro. Se ci sono molte persone che non lavorano, esse non sono disoccupati involontari: vuol dire che ai salari di equilibrio esse non desiderano lavorare. La forma mentis indotta dal modello neoclassico – di fronte ai fenomeno evidente di un crollo imprevisto della produzione e dell’occupazione – trova il colpevole nel mancato funzionamento di mercati competitivi, nell’interferenza dei sindacati e dello stato, in una politica monetaria sbagliata. Sulla base di queste diagnosi fu elaborata la disastrosa risposta alla “grande depressione” degli anni trenta del secolo scorso.

John Maynard Keynes
È in questo contesto che intervenne una grande innovazione teorica, la rivoluzione keynesiana, basata proprio sul riconoscimento della fallibilità e riflessività delle decisioni degli agenti economici, agenti con conoscenze parziali e imperfette, che commettono errori. E, come ho già ricordato, gli errori si sommano, le aspettative non si verificano e conducono sempre più lontano dall’obiettivo desiderato. Di qui il suggerimento che, per spezzare un circolo depressivo, lo stato dovesse intervenire per iniettare domanda nel sistema, ad esempio attraverso opere pubbliche: le aspettative degli imprenditori si sarebbero modificate e ci si sarebbe avvicinati a condizioni di pieno impiego. Questa rivoluzione teorica –qui non posso descrivere la sua struttura formale ma solo rinviare a due buoni libri, da poco pubblicati, che la descrivono in modo comprensibile anche da uno studente di scuola media superiore: G. La Malfa, John Maynard Keynes, Feltrinelli e Jesper Jespersen, John Maynard Keynes, Castelvecchi- ebbe un grande successo e fu alla base del lungo periodo senza crisi che i paesi sviluppati conobbero tra il dopoguerra e gli anni 70 del secolo scorso. Buona parte degli economisti non abbandonò, tuttavia, il modello neoclassico in cui erano stati educati e non accolse il messaggio più dirompente della nuova teoria, quello secondo cui, a seguito a seguito delle condizioni di incertezza in cui si formano le aspettative degli agenti e dei fenomeni di riflessività che le dominano, i mercati non conducono necessariamente a condizioni di piena occupazione: l’idea di “equilibrio di sottoccupazione” è una bestemmia per un neoclassico. Si moltiplicarono allora i tentativi di riconciliazione fino a che il messaggio keynesiano – complice anche un mutamento di contesto in cui non era più dominante il problema della disoccupazione, ma quello dell’inflazione- è diventato minoritario. Ed è tornata ad essere dominante l’idea che non bisogna interferire con le forze di mercato mediante interventi pubblici, poiché il mercato, lasciato a se stesso, si aggiusta da solo. L’idea è dominante ma non esclusiva: esiste infatti un’ampia corrente keynesiana –i suoi esponenti più noti sono i due premi Nobel Joseph Stiglitz e Paul Krugman- che la combatte con buoni argomenti: l’illusorio scientismo del passato è in crisi ed oggi l’economia appare sempre più simile alle altre scienze umane, in cui non esiste un unico paradigma ma tanti e in conflitto tra loro.
- La crescita economica
Anche su questo grande problema, che l’economia non può escludere dal suo raggio di spiegazione, il modello neoclassico non produce risultati soddisfacenti e altre modalità di spiegazione, più modeste e circoscritte, hanno preso il sopravvento. Quale è il problema? In un contesto comparativo più ampio, è lo stesso degli economisti classici: capire perché sono diversi i tassi di crescita di diverse economie. E, avendolo capito –teoria- come fare per accrescerlo, se lo si ritiene insufficiente -ingegneria. Il modello neoclassico della crescita deriva dalle funzioni di produzione della teoria neoclassica una risposta banale, ancor prima che insoddisfacente: cresceranno di più i paesi che aumentano maggiormente l’occupazione e gli investimenti, i due principali fattori di produzione, in conseguenza della maggiore produttività del lavoro (misurata dai salari) e del capitale (misurata dal saggio di profitto). Ma queste influenze spiegano di solito solo una parte modesta del tasso di crescita e lasciano un ampio “residuo” non spiegato, attribuito solitamente al progresso tecnico e organizzativo: questa la conclusione di che ha cercato di confrontare il modello con i dati disponibili, Edward Denison, verso la fine degli anni 60 del secolo scorso. Ma perché tale progresso è più intenso in un paese che in un altro? Fiumi di ingegno sono stati versati per cercare un risposta sostenibile in via generale, basata su un modello scientifico comunemente accettato. Di fatto, l’intera economia dello sviluppo è caduta al di fuori della teoria economica neoclassica: non c’è un modello “vero” che funziona in tutte le situazioni e il problema sembra essere quello di trovare quale modello, quale tipo di spiegazione, funzioni meglio in quale contesto. Un’arte, più che una scienza, sostiene Dani Rodrik, tra i migliori economisti dello sviluppo oggi viventi (La globalizzazione intelligente, Laterza).

Daron Acemoglu
Quest’arte ha però un nome, è storia, storia ragionata, storia comparata, intessuta di modelli scelti ad hoc, di “favole”, come le chiama Akerlof. Dopo di che uno storico-economico saggio ed esperto può mettere insieme queste “favole” per vedere se da esse si possono trarre generalizzazioni plausibili e derivare consigli per stimolare la crescita. Recentemente hanno tentato questa impresa Daron Acemoglu, un economista, e James Robinson, uno scienziato politico. Dopo dieci anni di lavoro e numerose pubblicazioni specialistiche hanno scritto un libro di sintesi per un pubblico più vasto dal titolo Perché le nazioni falliscono (Saggiatore: avrebbero anche potuto intitolarlo “Perché invece qualcuna ha successo”), una lunghissima carrellata di storia universale, con dozzine di casi nazionali o regionali studiati con maggiore o minor dettaglio, dalla caduta dell’impero romano alla Cina di Deng Tsiaoping, dalla Venezia del settecento all’impero Incas, dalla nascita del capitalismo industriale in Inghilterra all’Argentina dei nostri giorni, un libro perfettamente accessibile (e molto istruttivo e divertente) per un ragazzo di liceo.
In una grande quantità di esperienze storiche, le cause del divaricarsi dei destini economici, dei successi e dei fallimenti, Acemoglu e Robinson le trovano soprattutto al di fuori dell’economia, nelle istituzioni e nell’organizzazione politica. Istituzioni e sistemi politici che loro chiamano “estrattivi” (di sfruttamento, potremmo anche dire) impediscono parità di condizioni e libertà di iniziativa per la maggioranza dei cittadini, ostacolano la formazione di sistemi legali che consentano loro l’esercizio di attività economiche dei cui frutti essi possano disporre con sicurezza. Istituzioni e sistemi politici “inclusivi” hanno un effetto opposto e l’iniziativa economica dei cittadini può svolgersi senza gravi ostacoli. Sistemi estrattivi frenano lo sviluppo, sistemi inclusivi lo favoriscono, ma Acemoglu e Robinson non pretendono di enunciare leggi generali: oggi nessuno studioso avvertito pretende di enunciare una legge storica, alla Karl Marx. E tuttavia, con tutta la cautela necessaria, dalle loro ricerche possono trarsi suggerimenti utili per chi voglia capire le ragioni della crescita o del declino di un paese: non è un caso che il miglior libro recente di storia economica italiana (Emanuele Felice, Ascesa e declino, Mulino) si affidi molto ai lavori di Acemoglu e Robinson. Lavori di questo tipo, certo non “scientifici”, sono il massimo di generalizzazione, di ricerca di analogie e uniformità, che si possa raggiungere in materia di sviluppo economico, un problema che poi, caso per caso, occorre lasciare agli storici.
- Conclusioni
Attraverso il caso dell’economia, la scienza sociale che maggiormente ha cercato di assimilarsi alle scienze naturali, alle scienze “vere”, ho cercato di dare un’idea di perché si tratti di un obiettivo irraggiungibile. Irraggiungibile e sbagliato: se “spiegare”, nelle scienze umane, deve passare attraverso la comprensione delle ragioni – delle motivazioni, delle convinzioni, delle conoscenze – che inducono le singole persone a decidere come decidono e a comportarsi come si comportano, e sono poi gli esiti d’insieme di queste decisioni e comportamenti quello che vogliamo spiegare, allora l’obiettivo di scoprire leggi precise e immutabili come quelle delle scienze della natura è impossibile e distorsivo. Rimangono però, le scienze sociali, imprese conoscitive di straordinario fascino e interesse, e ciò proprio perché necessitano di qualità diverse da parte degli studiosi che le affrontano, dalla capacità di concentrazione e astrazione dei matematici alla curiosità e all’abilità di ammassare e connettere dati e informazioni degli storici.
Certo, controversie e differenze di opinioni sono destinate a rimanere e a mischiarsi inevitabilmente con dissensi politici e morali. Ma, come diceva Mao Tsedong, “grande è la confusione sotto il cielo: la situazione è eccellente”.
.
